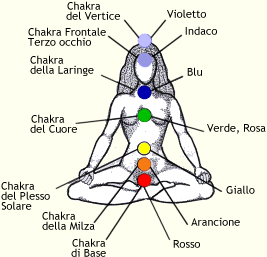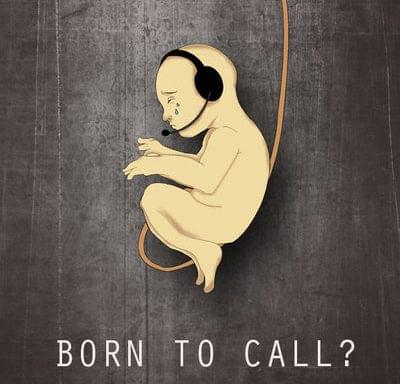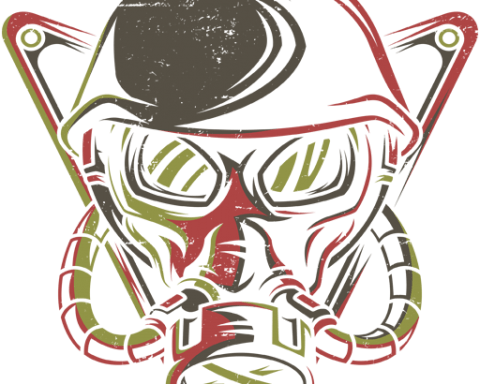di franc’O’brain
Maraen, hoe moogt gy spies en lans verheffen tegen God? (…)
Orbene, come puoi tu, al cospetto di Dio, alzare i pugni e brandire l’arma? Cerca di capire le ragioni; il tuo braccio è innocuo anche con la spada. Nella tua commedia d’assassino ti curvi sopra il mondo opprimendolo col tuo peso, e il mondo si rompe in mille pezzi; ma Dio vede ogni cosa.
(Valerius: Neder-landtsche gedenck-clanck. Haarlem, 1626.)
«Adonái, Adonái», li sento implorare. E mi si rizzano i capelli.
È impossibile, penso. Aaah! Dev’essere un incubo. È come uno sballo mal riuscito. Ma mio cugino si limita ad aggrottare la fronte e non pronuncia parola, mentre, guancia a guancia, osserviamo da questa finestrella a forma di oblò la tecnica adoperata dai seguaci di Caleb per far fuori Johnny. Johnny: il nostro "fratellino nero". Lo hanno appeso al soffitto per le mani e i piedi e lo colpiscono con mazze da baseball. Come nel gioco "becca la pignatta". È chiaro che vogliono spingerlo a parlare, ma il ragazzo non ha niente da raccontare. D’altronde come potrebbe, con quella bocca? La sua non è più una bocca: è un buco sanguinolente. La voce è piagnucolosa e indistinta; si direbbe il lamento di un gatto piuttosto che un grido di dolore.
Quando il giovane indiano smette di agitarsi, un paio di Adonaidi gli allentano le corde e ne calano il corpo sul pavimento, per trascinarlo poi dentro uno sgabuzzino.
«Ecco che tornano», mi riscuote Victor. E mi tira via dall’oblò. La porta di metallo viene spalancata di botto e due robusti settari si piazzano sui lati. Quindi appare Caleb. Sento di avere le vene di cristallo e il sangue come limo. Mi accade ogni volta che vedo quest’uomo. (Uomo?) Mio cugino invece si ostina a mantenere la sua aria flemmatica.
«Tre è un nümero sbagliato, o peccatori», sentenzia Caleb. «Siete rimasti in due. Ancora troppi, comünque. A chi tocca?»
Incontro il suo sguardo buio. Un’orbita è vuota. Poi scorgo il bicchiere che regge in mano. L’occhio di vetro è lì, dentro il bicchiere, in una soluzione di acqua borata; e mi fissa.
«Vi spiace per il vostro amico, eh? Ma abbiamo dovüto farlo», continua Caleb. «È la volontà di Adonái. Atei! Comünisti! Perché siete venüti qui?»
La sua sagoma – noto con un fremito – non getta ombra. Caleb è inverosimilmente magro e pallido; un animale rosso di pelo paludato in un lungo mantello nero. Se non ci fossero i suoi sgherri a spalleggiarlo, non lo si prenderebbe minimamente sul serio, con quel suo fisico da beccamorto e le sue ü da montanaro.
«Non dite nülla, eh?» riattacca. «Va bene. Mai letto la Bibbia? Proverbi. Capitolo 26, versetto 3: "La früsta per il cavallo, la cavezza per l’asino e il bastone per la schiena degli stolti".» Nuovamente mi sento osservato da quegli occhi: uno nell’orbita e l’altro dentro il bicchiere.
«Tu!» mi si rivolge ad un tratto, puntando un dito a uncino.
Mi si piegano le ginocchia. Ecco, penso, è il mio turno… Ma di colpo Victor si fa avanti e prorompe: «No, Caleb! Punisci me».
Calmo, coraggioso, folle. Un nobile cavaliere, un idealista. Mi dico: mio cugino è proprio cambiato, negli ultimi anni. È difficile stargli dietro. Ha tutta l’aria di chi vuole bruciare in fretta e un’energia tale da farti mancare il fiato. Offrendosi in vece mia, spera forse di salvarmi la vita. Molto generoso da parte sua, anche se dubito che qualcuno arrivi a soccorrerci. Nessuno, infatti, sa che siamo qui.
Caleb pare stupito da tanto spirito di sacrificio. Piacevolmente stupito. Ha messo su uno dei suoi sorrisi da rettile. Dopo qualche attimo, annuisce impercettibilmente e, con la mano che regge il bicchiere, fa un cenno ai suoi mastini. «Il sangue è l’estasi», lo sento esplicitare, mentre ci mostra la nuca cadaverica. E, volatizzandosi, scoppia in una delle sue lugubri risate: una specie di stridio pipistrellino che rimbomba a lungo tra le pareti del rifugio (o "catacomba", come la designano i suoi adepti).
I due sgherri afferrano mio cugino per traslarlo di là, nella sala di tortura, e soltanto mentre la porta bullonata sta per richiudersi vengo sopraffatto da un rigurgito di rimorso. Precipitandomi sullo spiraglio, urlo: «Nooo!… Victor!» Uno degli Adonaidi cerca di respingermi all’interno, ma io continuo ad aggrapparmi alla porta. E allora quel bastardaccio mi rifila un gancio.
Una botta epocale che mi manda a gambe all’aria. Stordito, scrollo la testa e mi rendo conto di avere la mascella slogata. Un dolore infame. Mi sono già buscato un pugno nell’occhio quando ci hanno scoperti, e ora quest’altro guaio. "Sarei dovuto rimanere in città" ragiono tra me e me.
Mi rialzo a fatica e il mio sguardo cade su una delle pareti. Là c’è una grossa macchia scura che non avevo ancora notato. Focalizzo meglio e vedo che si tratta di un ragno. Non poggia direttamente sul muro, ma pende dal soffitto. Un insetto mostruoso e schifido che mi osserva a sua volta.
È bello grasso, ‘sto ragno. Mi sorprendo a pensare che, se non avesse un’apparenza talmente viscida, lo si potrebbe scambiare per un giocattolino cibernetico. Ma – rifletto – nessun coso artificiale potrebbe rilucere e palpitare in quel modo.
La mascella penzolante, mi metto a camminare su e giù per la cella, il più lontano possibile sia dal ragno sia dall’oblò. Johnny ha fatto una brutta fine, e adesso c’è Victor di là. Che gli è saltato in mente? mi dico. Ero io la vittima designata…
Povero cugino! Non me la sento di guardare. Che fare? Mi pare di ammattire in questa cella dalle pareti cavernose. Non mi resta che camminare su e giù, su e giù… come un matto, appunto.
Intanto cerco di ricapitolare gli avvenimenti degli ultimi giorni, in modo da renderli chiari a me stesso.
Sono di nuovo a Pietragialla da quattro giorni. Pietragialla: il paese che mi ha dato i Natali. E non solo i Natali: anche i carnevali. Non provate a cercarlo sulla carta geografica perché non è segnato da nessuna parte. Vi basti sapere che qualche anno fa, stancatomi della monotonia di questo posto rurale, mi trasferii nella metropoli con la scusa di studiare. Nel Moloch di vetro-cemento-acciaio mi ritrovai a vivere in uno squat, un appartamento occupato da tipi assai strani. Persone che presto si sarebbero rivelate essere necrofili che andavano per cimiteri a riesumare salme. Io comunque non ero molto più normale di loro. Ogni grande città incoraggia alla deboscia, e il sottoscritto evidentemente è nato con il genoma del debosciato: ero sempre in giro a bere e a farmi di qualcosa, senza tregua. Non dimenticherò mai quella volta in cui, scorrazzando per le vie del centro dopo essermi rimpinzato di ketamina (ahiahiahi, ‘ste nuove droghe!), vidi un cane che volava all’altezza della mia cervice suggerendomi i posti in cui recarmi.
Parte dei soldi per la roba me li aveva procurati Victor, sia pure indirettamente. Una volta, a casa sua, avevo sottratto di nascosto un quaderno pieno di suoi versi e di suoi aforismi, che ora andavo vendendo a riviste e rivistucole varie, ovviamente dopo averli firmati col mio nome.
Sniffavo o mi bucavo nella relativa solitudine dei cessi della metropolitana. Di giorno solitamente dormivo, ma il mio sonno si faceva sempre più agitato, i sogni erano melmosi. In facoltà, logicamente, non mi videro più: affrontare le normali incombenze del quotidiano mi risultava impossibile, figurarsi se potevo concentrarmi sui libri di testo! Stavo diventando pure paranoico: sospettavo che quelli della narco mi avessero messo una cimice nel cervello per origliare i miei pensieri. Inutile dire che, dovunque andassi, davo nell’occhio, e i bravi cittadini non avevano remore a farmi capire senza mezzi termini quel che pensavano del sottoscritto.
Ce l’avete con me? Ma perché? Lasciatemi sballare, ballare… Che ve ne cala?
Niente andava per il verso giusto, né all’Uni(versità) né fuori. Credevo che il mondo intero fosse impazzito… o che io fossi un alieno. Non solo venivo respinto e preso in giro dai commessi dei negozi di dischi: anche bidelli, buttafuori di discoteche, sergenti maggiori, docenti e aspiranti futuri suoceri mi mettevano i bastoni fra le ruote. Il "sistema" era, a mio parere, una mafia bell’e buona, e io la mosca destinata a impigliarsi nella rete.
Quando una tizia alla quale tenevo particolarmente mi abbandonò, decisi di fare una virata di centottanta gradi e di tornare allo status quo ante: ovvero all’innocenza dell’età adolescenziale.
La terra dei padri: Pietragialla. Sempre più di frequente il paesino si intrufolava nei miei pensieri sotto le mentite spoglie di un paradiso perduto. Pietragialla. La rustica saggezza degli avi. E i campi rigogliosi, flowerpower. Per tacere del timido, tranquillo cuginetto.
«Torno in paese perché ho voglia di rivedere Victor», dichiarai ai miei strambi coinquilini. «Victor per me era come un fratello, anzi più di un fratello. Certamente anche lui sarà contento di rivedermi…»
La gang di necrofoli accettò la mia decisione, ma non volle lasciarmi partire senza che prima facessimo una visitina alla nostra bettola favorita. Oh, quella mia ultima sera in città! (Non mi sembra vero, ma risale a soli cinque giorni fa.) Ci siamo ubriacati come se volessimo farla finita con la vita. Abbiamo mischiato di tutto: birra, whisky, Captain Morgan – 73 per cento di alcol puro -, Jägermeister a litri… tanto che persino il gestore del locale cominciava a preoccuparsi.
Il mattino dopo montai sul treno in stato semicomatoso, dicendomi: "In fondo, ogni città è piena di coglioni e bastardi rognosi buoni a nulla". Sì, via, via! Victor, il gentile e modesto Victor, l’angelo dei miei anni spensierati, si sarebbe curato di riportarmi sulla giusta strada con la forza della sua anacronistica purezza.
Odo un gemito più forte provenire di là. Non resisto, non posso farne a meno: scrutando di sottecchi il ragnaccio, torno ad avvicinarmi all’oblò. E vedo…
Victor è appeso per i polsi. Il naso è rotto, metà dei denti manca. Un occhio è chiuso forse per sempre, mentre l’altro fissa inorridito i cavi elettrici che uno degli uomini di Caleb (chiamiamolo X) gli tiene vicino al volto. Poco discosto, un altro fanatico (K) ride come una pentola borbottante. Un terzo (S) invece sta zitto, tutto teso in un’aspettativa eccitata; regge in una mano una pinza chirurgica, nell’altra un rasoio.
«Apri», ordina X a quest’ultimo.
S ubbidisce: infila la pinza nella bocca del prigioniero. Ma il prigioniero fa resistenza, stringe i denti che gli rimangono.
«Si oppone», constata S. «Che faccio, taglio?»
X annuisce. S solleva allora il rasoio e, senza esitazioni, recide a metà il labbro inferiore di Victor. Mio cugino caccia un urlo terrorizzato, e a questo punto la pinza gli penetra nella bocca, tenendogliela innaturalmente spalancata. Con prontezza, X balza in avanti e introduce i cavi elettrici scoperti: uno sulla lingua e l’altro sul palato di Victor. Il malcapitato prende ad agitarsi come se avesse il ballo di San Vito.
Un istante prima che Victor perda coscienza, X ritira i cavi. K, il terzo uomo, è rimasto a guardare per tutto il tempo. È madido di sudore. Si nota bene che è finanche più eccitato dei suoi compari…
Madido di sudore, mi ritiro dalla superficie di plexiglas dell’oblò. Sto tremando come una foglia e strizzo gli occhi come per spararmeli all’interno del teschio. Barcollando, torno verso il cantuccio più distante e, raggiuntolo, mi accascio. È palese che gli Adonaidi vogliono liquidarci tutti. Non ho scampo, così come non ne ha Victor e come del resto non ne ha avuto il piccolo Johnny. Per questi settari, per questi adepti di un monaco folle, non si tratta di scoprire il perché siamo venuti a ficcare il naso nel loro tempio – o "catacomba" -, ma semplicemente di far scorrere sangue. In onore di chi? Di Adonái? Un nome che ogni tanto ricorre nel Vecchio Testamento. Una divinità maligna, a quanto sembra; assetata di clorofilla umana. Ma è più probabile che sia Caleb, nella sua follia, ad essersi inventato un dio vetusto, arteriosclerotico, perfido. Una cosa è certa: è lui, lo sciamano sceso dai monti, ad avere assemblato questa orchestra del male, che dirige con spietata precisione.
Maledizione! Perché siamo venuti in questo posto?
Guardo in alto. L’occhietto rosso dell’insetto continua a starmi appiccicato addosso, ma non può evitare il dipanarsi della pellicola dei ricordi.
Uscire dalla città significò per me rivedere sgorgare il sole. Per un lungo tratto dormii spaparacchiato sul sedile, con i raggi dorati che mi baciavano il volto. Mi svegliai mentre il treno infilava l’ultima curva prima della dirittura d’arrivo. "Victor" pensai con un sorriso quasi compassionevole. Chissà se scriveva ancora poesie! In un’epoca di Rambi e Terminatori che, a conti fatti, rambeggiavano e terminavano più che altro se stessi, Victor e la sua bohéme erano fuori posto come un uovo di gallina in un nido d’aquila. Già si formavano le prime Silicon Valley europee, eppure mio cugino si impuntava a voler fare l’artista. A Pietragialla, poi! Il che equivale a dire nel buco di culo del mondo.
Sporgendomi dal finestrino, scorsi laggiù, sulla banchina che si avvicinava, due perfetti sconosciuti: il mio comitato di ricevimento. Uno era alto, muscoloso, abbronzato e portava i capelli lunghi; l’altro, minuscolo e scuro, rideva con denti bianchissimi.
Quando saltai giù dal predellino, mi accorsi che l’Adone -tipo Antonio Banderas -era il cuginetto.
«Però! Sei cambiato», gli dissi, ancora nell’abbraccio.
Lui mi rispose sibillinamente: «Sono sempre io. Solo che prima tu vedevi l’image, mentre questa è l’afterimage».
«Mmm. Devi comunque ammettere che, almeno fisicamente, un certo cambiamento è avvenuto. E causato da che?»
«Non "che" ma "chi"», corresse lui. Mi narrò di aver conosciuto una certa ragazza. «Poi è entrata in una setta…» Lasciò la frase in sospeso.
«Una setta? In città?»
«Ma no. Qui.»
Lo guardai incredulo, mentre alle mie spalle il treno ripartiva, bellamente ignorato. «Vuoi dire qui, da noi? A Pietragialla? Una… setta?»
Victor annuì cupo. Quindi indicò il piccoletto dall’aria di straniero che era rimasto per tutto il tempo nella sua ombra. «Questo è Johnny», annunciò. «Il mio "fratellino nero".»
Caspita! pensai. Uno straniero nel nostro sperduto paese? Proprio vero: in poco tempo possono mutare tante cose.
Mentre scarpinavamo verso casa, insistei per ascoltare il resto della storia. «Così quella ragazza ti ha abbandonato?» domandai. «Per entrare in una congrega religiosa?»
Di nuovo, Victor annuì. Mi raccontò che, in seguito alla delusione, aveva infilato alcuni indumenti in uno zaino e aveva lasciato il paese. Se n’era andato in giro come un hippy post literam: Ticino, Austria, Provenza… A piedi!
Inconcepibile per me. Inconcepibile che Victor fosse uscito da Pietragialla. Ma anche che qualcuno possa compiere lunghi tragitti a piedi. Io, ad esempio, mi sposto volentieri in auto. D’accordo, non ho ne mai posseduta una, ma, quando potrò permettermela, essa diventerà sicuramente la mia seconda dimora. In città ho scoperto comunque che metrò, treni e tram rappresentano un valido palliativo alle quattroruote. È come se queste gabbie di Faraday fossero state costruite giusto per me. Ma siamo tutti così, ovviamente. Siamo una "in-car nation". La macchina (il metrò, il treno, il tram) è una sorta di isolatore spirituale. Capace di darti uno sballo di livello medio-alto.
«E quindi sei uscito da Pietragialla per vedere il mondo», commentai. «Sorprendente.»
«Sì», rispose mio cugino, tutto serio. «Sono un global player.»
«In che senso?» chiesi, stupito di sentirgli pronunciare quei termini in inglese.
«Ho imparato a giocare con le differenti realtà della vita. Lo sai: the winner takes it all e tutto il resto.»
«Ah, già, già…»
«Ma niente paura: non ho smarrito la Via. Soprattutto grazie all’amicizia di Johnny.»
Sbirciai quello scricciolo d’indiano (il quale continuava a ridere silenziosamente, in armonia con l’universo intero) e mi rifiutai di aggiungere alcunché.
Dalla sala di tortura i gemiti riprendono più forti. Esasperato, mi getto verso la porta di metallo e raspo come un cane. Ma nessuno mi apre. Allora mi tiro su e riprendo a occhieggiare. Incorniciato dalla finestrella a forma di oblò c’è Victor, che con quella capigliatura assomiglia a un Cristo in croce. Si sta pisciando addosso. La scarica elettrica lo ha quasi ucciso.
«Ora noi ce ne andiamo», dice S al prigioniero, «ma torneremo presto.»
Lui e X ripongono gli attrezzi di tortura, e X (che dev’essere un luogotenente di Caleb) ordina a K: «Rimani di guardia, tu. E fa’ un po’ di pulizia, se puoi».
«Okay», risponde K. Attende finché i due non sono usciti, poi si riscuote con un sospiro. Va a bagnare una spugna nel lavabo dell’ex rimessa e, con la spugna gocciolante, si avvicina alla vittima. «Ti ammazzeranno, lo sai?» gli dice. «Perché non gli spifferi chi ti manda? La polizia? Il fisco? Gli Avventisti?» Infila la mano libera nel saio e trae una Luger. «Forse dovrei, per pietà…» Punta l’arma. Ma si trattiene dallo scaricargliela addosso, perché sa che X e S vogliono il prigioniero vivo: per divertirsi con lui il più a lungo possibile. Caleb ha dato loro carta bianca. «Oh, ma guarda qui…» K scuote la testa. Il corpo di Victor è incrostato di luridume; lo percorrono rivoletti di sangue e mucopus. «Uno schifo», commenta il carceriere, pur ridacchiando. Poggiata la Luger su un tavolinetto, mette in azione la spugna, ben attento a non calpestare l’urina e le feci che costellano il pavimento sotto e tutt’intorno a mio cugino.
Da quanto tempo ci troviamo nella Casa di Adonái? Quarantotto ore all’incirca. Prima che loro venissero a prendere Johnny per ammazzarlo come una bestia, abbiamo assistito in tre (guancia a guancia a guancia) alla tortura di un vecchio vagabondo. Dapprima gli hanno rotto un paio di costole a stivalate, là fuori nel giardino, dove il vecchio dormicchiava su una panca. Poi lo hanno trascinato dentro la rimessa riattata a sala di tortura. Qui non lo avrebbe trovato nessuno… Uno dei discepoli avrebbe voluto riprendere la scena con una videocamera, ma Caleb si era infuriato: nessuna traccia, nessuna testimonianza.
«Impissel!» aveva ordinato. «Accendetelo!» E, tra le fiamme, il vagabondo si era letteralmente squagliato, lasciando soltanto alcune macchie marrò, mentre Caleb tuonava oscuri motti biblici.
A proposito: dov’è adesso il monaco pazzo?
Ma non c’è tempo per le domande. Osservo K abbassare la spugna sui genitali di Victor e lo sento esclamare: «Oh».
In effetti, mio cugino ha un’erezione tremenda.
«Oh», echeggia una voce fuori campo. Quella di una ragazza. Poco dopo vedo di chi si tratta: è una delle neofite. Non una qualsiasi, ma Valeria. Lei e il prigioniero si guardano lungamente, e l’aria si riempie di vibrazioni cruciali.
Io Valeria me la ricordavo come una bambinetta sciatta. Quando sentii che era lei la squinzia che aveva filato con mio cugino, ero scoppiato a ridere. Ma poi l’avevo vista mentre, in tonaca bianca, si recava al tempio… alla Casa di Adonái… insomma: a questa gabbia di matti sorta alle porte del paesino. Pelle latte e miele, bocca di fragola, uno sguardo tra innocenza e calda promessa. Una donnina sensuale.
«Ah, ora capisco», dissi compiaciuto a Victor. «Hai trovato Eva Vergine, eh?»
«Vergine? Non più.»
«Perché hai pensato tu a…»
«No, io non ho più fatto in tempo», ribatté mio cugino.
«Oh. E allora chi…?»
«Chiedilo a Caleb», aggiunse lui con espressione rannuvolata. «È il capo di quella setta.»
Valeria era l’ultima nata di una famiglia di contadini che vantava otto figli: sette maschi e una femmina. Le prime voci cominciò a udirle a undici anni, e poco più tardi ebbe le prime visioni. L’avvento di Caleb in quei paraggi non poteva che sembrarle un segno del Cielo.
Nel nostro paese, la verginità è un dono che si riserva al futuro sposo. Una prassi in vigore da chissà quanti secoli. Ma, quando Victor aveva messo le mani addosso alla ragazza, l’aveva scoperta già esperta.
«Perché lo vuoi sempre dentro subito, con prepotenza?» le diceva. «Ci si può amare anche con tenerezza. Anche solo con gli occhi, o con la punta delle dita.»
Niente da fare: di lei aveva già abusato Caleb, inculcandole la logica perversa della sua "dottrina". Naturalmente, Valeria si era accorta che Victor era diverso. Più amorevole, più delicato. Ma, dopo un po’ di sesso con lui, tornava puntualmente a rifugiarsi nel tempio.
«Ogni giorno di più, lei diventava tierra incomunicada», mio cugino concluse il suo racconto con profonda tristezza. «Finché non l’ho persa del tutto.»
La ragazza si china sul membro di Victor, producendosi in un classico esempio di fellatio. Poi torna a rizzarsi e, con un sorriso da meretrice, esclama: «Però!» E si lecca le labbra. Mio cugino la osserva con il suo unico occhio. La osserva, la osserva…
La vedo arrossire. Si sente fragile, sottomessa, umiliata da quello sguardo. Ma non appartiene più a lui. Non gli è mai appartenuta. È la servetta di Adonái o di chi ne fa le veci. Ovvero di Caleb.
Da quel che ho sentito sussurrare in piazza, e dai vaghi accenni di mio cugino, so che Caleb è un ex prete. In seguito ha fatto il mago; forse anche il maestro di scuola e il barbiere. Ha viaggiato operando incantesimi ed è stato arrestato più volte con l’accusa di pedofilia. Si vocifera che a Torino abbia compiuto una truffa che gli avrebbe fruttato una bella cifretta. Ricorre spesso a soprannomi per mascherare le sue precipitose partenze. Già prima che creasse il culto di Adonái, intorno a lui cominciarono a formarsi le leggende più avventurose.
Non mi è difficile immaginare che Valeria veneri questo falso santone, concedendoglisi senza ambagi di sorta. Gli si butta ai piedi, si aggrappa alle sue ginocchia… Come i deliri di una quindicenne che tenta di strappare un brandello di camicia alla rock star. Il vecchio porco, ovviamente, abuserà del suo corpo finché ne
avrà voglia.
«Vien qui che ti ciülo.»
«Sì, Maestro, sì. Mostrami Adonái!»
Nel refrettorio, Caleb la umilierà davanti a tutti: «Sta’ zitta, tü! Ti ho forse detto io di aprir bocca? "Come in tütte le comünità di fedeli, le donne nelle assemblee tacciano perché non è loro permesso parlare". Corinzi 1. Capitolo 14, versetti 34-35».
In ultimo, la scaricherà come una bambola inutile.
La verga di Victor, galvanizzata da secoli di esperienza solinga, reagisce ai minimi movimenti della ragazza. Lei ne è affascinata. Eccolo là il monolito, la Pietra dei Saggi. Eccolo, splendido come un giorno di sole…
Intanto K gira intorno ai due, anche lui con un’erezione terribile. Precedentemente, lui o qualche altro sgherro di Caleb ha infilato nell’ano del prigioniero un manico di scopa. Ora K sfila il bastone con cautela. Un leggero sibilo, insieme al rantolio di Victor, accompagnano l’operazione. «Così è meglio, eh?» chiede K.
«Aiutami, Valeria!» supplica il prigioniero.
Ma lei, che nel frattempo si è spogliata, gli si butta addosso come una cagna infoiata, alzando una gamba. È bella, pallida d’avorio. Avoriopallida.
Da tergo, anche K si dà da fare. «Scusa amico, ma nella vita terrena bisogna provare ogni cosa», ride.
Mi trovavo in paese da due giorni quando Victor prese l’improvvida decisione di liberare la sua donzella dalle grinfie dei settari. «Devo convincerla a venir via da lì», dichiarò.
Sulle prime sospettai che fosse preda di un pizzico di psicosi da trip. Forse Valeria lo aveva abbandonato per un altro e lui ora addossava la colpa a quei seguaci di una nuova religione. Ma non era una psicosi da trip. Victor non ha mai assunto in vita sua sostanze neurolettiche.
Così, una notte ci demmo appuntamento per recarci alla Casa di Adonái. Pur se dubitavo fortemente sulla riuscita dell’impresa, non me la sentivo di lasciare in asso il cugino. Faceva freddo e battevo i denti, ma quando vidi arrivare Victor e Johnny mi si scaldò il cuore. Formavano una simpatica coppia di amici, come in uno di quei telefilm che guardavo da bambino: uno era di colore e l’altro (mio cugino), per malasorte nato povero di melanina, si era procurato l’abbronzatura artificiale. Ci incamminammo su un sentiero malsicuro mentre all’orizzonte scoppiava un cacchio di temporale elettrico stile Manhattan, con tuoni e fulmini da sballo. Io incespicavo a ogni passo. Mi sembrava un sentiero di merda, invece era la tangenziale per l’inferno.
«Ahò, è molto pulp!» osservai.
«Finanche troppo», replicò il cugino.
Johnny taceva. Chissà a che cosa pensava! Io e Victor siamo venuti su a forza di merendine, frappé e film d’avventura. Siamo figli del bùm! Del boom economico, cioè. Più tardi il boom si sarebbe rivelato essere una bolla di sapone, e oggi i nostri padri ripongono tutte le loro speranze sul totocalcio: l’unica ipoteca su un futuro improbabile.
Johnny proveniva da un ben altro pianeta, perciò mi chiedevo come faceva a conciliare le sue credenze buddiste con la vita squallida che era costretto a condurre nel nostro paese, dove aveva trovato un’occupazione come manovale. «Trasportatore di mattoni», amava specificare lui stesso.
Su quel sentiero al buio, ci sentivamo un po’ eroi. Ma ci pesava addosso la tragicità del momento. E la solitudine. Eravamo tre anime sperdute sotto l’ammasso di galassie indifferenti.
Ad un certo punto chiesi a mio cugino: «Che ne hai fatto delle poesie che scrivevi?»
«Perché? Vuoi tentare di venderle a nome tuo?»
Accidenti! Un pensiero del genere non me lo sarei mai aspettato da lui. Il Victor di prima non mi avrebbe mai giudicato capace di una simile insania. «Cavolo, io l’ho chiesto perché mi interessa leggerle. Come puoi credere che…? CI MANCHEREBBE ALTRO, NON CERCHEREI MAI DI FARTI UNO SGARBO DEL GENERE. Anche se ci riuscissi, la sola idea mi metterebbe a disagio, e…»
«Calmati, Brutus.»
Mi calmai. Tuttavia ero deluso. D’accordo, era un bel po’ che non ci beccavamo, ma com’era possibile che lui avesse una tale opinione di me? Sì, un quadernetto glielo avevo fatto sparire, ma… Mi ripromisi di farlo ricredere totalmente sul mio conto, dandogli tutto il mio appoggio in quell’operazione.
Giungemmo finalmente davanti a un giardino pieno di inferriate. La casa era circondata da una nebbia che ingolfava il respiro. Dalle finestre filtrava uno smorto chiarore. Quatti quatti girammo attorno all’edificio e, a un certo momento, mio cugino si arrampicò sulla recinzione, agile come una pantera. Johnny lo seguì: anche lui senza apparente difficoltà. Io, al contrario, faticai non poco. Il piede mi scivolava di continuo sulle sbarre umidicce. Arrivato in cima, ebbi paura persino a girarmi per ridiscendere dall’altra parte.
«Buttati», sussurrò Victor. «L’erba attutirà la tua caduta.»
Volsi la testa e guardai in basso: vedevo i miei due compagni come attraverso un cannocchiale, un cannocchiale tenuto dalla parte sbagliata. «Troppo alto», dissi con voce querula.
«Buttati!» ripeté perentoriamente Victor.
Ubbidii. Fu come andare in immersione in un nero di seppia. Mancava poco che mi tappassi il naso con due dita. Ma l’impatto seguì fin troppo presto. Rovinando sul prato, mi lasciai sfuggire un: «Minch!»
«Ssst», fece Victor. Troppo tardi: qualcuno ci aveva visti, o aveva sentito me, e aveva già provveduto ad adunare gli altri mastini. Ci fu una breve colluttazione (da qui il livido sull’occhio) e dopo un po’ ecco che ci sospingevano all’interno della cella blindata, dove ci osservarono con facce totalmente prive di espressione. Credevo di non conoscere nessuno di quegli individui, anche se alcuni di loro erano incappucciati. "Abitano in paese e non vogliono rivelare la loro identità" supposi.
Quando arrivò Caleb, seguito da una dozzina di novizie festeggianti, mi bastò guardarlo perché le mie vene si cristallizzassero. Poi mi accorsi che Victor mi tremava accanto; avvertii la calotta del suo cranio lanciare ticchettii mentre si restringeva. Ma il cugino non aveva freddo, né tantomeno paura. Era rabbia, la sua. In una delle ragazze sciamate dietro lo sciamano aveva riconosciuto… lei.
K continua a dimenarsi aggrappato alla schiena di Victor e ogni tanto lancia un: «Adonái, Adonái!»
Poi gli gira attorno, il cazzo ancora gonfio. Osserva la sinuosa Valeria darsi da fare addossata all’uomo; osserva l’uomo. Victor ha l’occhio sorridente. K impugna la Luger e, gesticolando furiosamente, costringe Valeria a staccarsi dalla vittima.
«Fuori!» ordina, rauco.
Valeria fa il broncio. Infine soccombe. Raccoglie la sua tonaca e si dilegua. Lanciato un grugnito affermativo, K poggia la Luger sul tavolinetto. La sua mano scatta come una lingua d’iguana verso il sesso di Victor. Lo studia meticolosamente. Quindi apre la bocca e si mette a succhiarlo con golosità, mentre lui stesso si masturba. Poco dopo risuona un urlo: triplice. Grida il prigioniero che viene nella bocca di K, grida K che viene nella propria mano e grida S.
S è entrato senza che K se ne accorgesse; K non si è accorto quasi neppure di avere il cazzo del confratello nel sedere…
I due aguzzini si rassettano alla meno peggio: S va a lavarsi sotto il rubinetto, mentre K si sfrega davanti e dietro con la stessa spugna sudicia con la quale ha ripulito il prigioniero.
Il capo, X, ritorna dopo un paio di minuti. Fumando. Si rende conto che qualcosa non quadra: S e K evitano di guardarsi negli occhi e il martire ha un’aria strana, tra l’allegro e l’accusatore. X si avvicina a quest’ultimo, gli si pone di fianco e gli spegne nell’orecchio il mozzicone della sigaretta.
Victor caccia un urlo straziante. «Caleb ha detto che possiamo usufruire di lui come meglio ci pare», ricorda X. «Facciamola finita, dunque.» S agguanta la Luger. Si piazza a un metro e mezzo da Victor. «Salutaci la nostra divinità», fa. E preme il grilletto.
Un violento getto di vomito mi fa barcollare all’indietro. Batto la testa contro la parete di fondo e, disteso per lungo sul pavimento, mi scopro a tremare violentemente. I miei occhi colmi di lacrime si puntano sul ragno, che adesso si libra giusto sopra di me.
"È un Pholcus phalangioides" constato.
Io non sono quell’asino che sembro. Da bambino amavo sfogliare i libri illustrati. Ne avevo uno che si intitolava Enciclopedia degli insetti, e l’immagine del Pholcus phalangioides -un ragno schifosissimo – evidentemente mi è rimasta impressa nella memoria. A quei tempi, il mostro entrava sovente nei miei incubi.
Lo sto a fissare; lui fissa me. Dopo, pieno di sgomento, mi accorgo che comincia a scendere con rapidità lungo il suo filo invisibile. E, più si abbassa, più cresce a dismisura.
Quando eravamo scolaretti, ci mandavano al circo una volta all’anno. «Vedrete come vi divertirete!» ripetevano le maestre. Ma per me quel giorno era un vero tormento. Ci sospingevano come una mandria dentro il tendone e poi, incasermati sugli spalti (i sedili, rammento, erano duri e freddi), eravamo costretti ad assistere alle scemenze dei clown e delle bestie addestrate. Sono state le rappresentazioni circensi a rovinarmi la vita… Ergo: è stata la scuola a fare di me quel che poi sono diventato.
Farnetico, lo so… Che colpa ne ha la scuola, in fin dei conti? Boh! Sarà anche vero che le maestre erano carine, ma a me tutto quel che è sinonimo di potere mi fa incazzare, figuriamoci poi loro… specialmente la fazione delle eterne frustrate. Più tardi me ne sono scopate un paio. Occhio per occhio dente per dente frappé per frappé.
Ahiahiahiahi! Sto delirando. Cerco di rimettermi in carreggiata. 3… 2… 1… 0.
Concentrati sul momento presente, Brutus! Concentrati!
Il ragno.
Ormai mi è addosso: enorme, schifoso. Ha un ciuffo di peletti rossi sulla testa, appena sopra l’occhio. Mi ha inchiodato al pavimento con le sue zampe ferree e si mette a parlarmi. Gracchiante astioso bieco.
«Sei una delüsione, Brütus. Non dovevi venire qui. Ma tra poco conoscerai Adonái, l’ünico Dio. Sarà Lui ad occüparsi della tua anima straziata.»
«Dio non esiste!» urlo.
Il ragno Caleb scoppia in una risata ruvida. La bocca è un orifizio scarlatto che pulsa, frangiato di tentacoli che battono all’unisono. Da essa esala un fetore micidiale: ammoniaca, fors’anche zolfo.
Declama: «"Come il cane torna al suo vomito, così lo stolto ripete le sue stoltezze". Proverbi. Capitolo 26, versetto 11».
La parte posteriore del suo corpo si piega verso di me, e il pungiglione…
«Una piccola iniezione sotto lo scroto», gracchia. «Invisibile. In seguito scaricheremo il tuo cadavere in aperta campagna. Nessuno saprà mai la causa della morte. Üno… due…»
Tre! L’ago mi penetra in profondità, e fiotti di lava incandescente percorrono le mie vene alla velocità della luce. Inarco la schiena. Quindi vengo sollevato da terra.
Salgo, salgo… Quando l’ago si ritira, comincia la caduta. È come precipitare dal 57simo piano. Alle mie spalle scorre una parete che presenta tutti gli strati geologici della Terra, tutti i tipi di minerali – dal silicio puro all’argilla. Sotto di me è l’Occhio.
Gigantesco. Mi guarda con fissità. E all’improvviso ho una cognizione fondamentale:
Adonái!
La caduta sembra non voler terminare, ma il Dio ha tempo da vendere: mi aspetta con pazienza in fondo al corridoio spaziotemporale.
Chi è? Chi è che vola così? Chi?
Ah, niente, niente. È solo Brutus.
Non è un nuovo Icaro, non è un Grande. Non ha inventato la polvere da sparo e non ha decifrato il bagaglio genetico dell’uomo. Un fallito come tanti. Un degenerato.
Nel cielo, in cui c’è tanto vuoto ma anche un traffico indescrivibile di velivoli e di uccelli, nelle eteree vastità azzurre e nere, vola uno che non conta niente. Uno che nessuno conosce. L’occhio cresce e cresce sotto di lui, e tutti i sensi di Brutus urlano, tutti i suoi muscoli si tendono nella tenebrosa premonizione dell’impatt
(…) maer God die siet het wel.