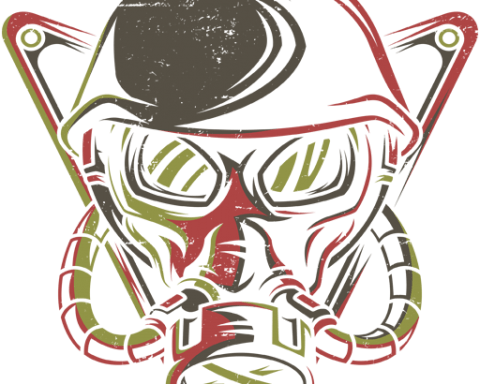di Sergio Givone
1) Carlo Canepa le chiede: “In questo periodo storico dominato dalla tecnica e dall’efficienza la sofferenza impera in quanto non siamo più capaci veramente di provare dolore di fronte al male?”
“L’impressione è questa ma mi chiedo se non sia soltanto un’impressione. Effettivamente i mezzi di comunicazione di massa rovesciano quotidianamente nelle nostre case immagini di malvagità devastanti e a tutto questo noi ci abituiamo, non possiamo fare diversamente. E’ intollerabile, sarebbe intollerabile convivere con la presenza di questo. Pensiamo ad epoche in cui il male non era filtrato dai mezzi di comunicazione ma era lì, era in strada, era in mezzo a coloro che vivevano la peste, che vivevano la guerra. Dovevano abituarsi per sopravvivere, dovevano assuefarsi. Ecco allora il problema si configura in modo un po’ diverso. Ciò che dobbiamo chiederci è se oggi non sia venuta meno la capacità di scandalizzarsi, la capacità di provare orrore e non solo questo, sia venuta meno la capacità di sentirsi responsabile anche di quel male che sembrerebbe non toccarci direttamente o non venire direttamente da noi. “Io dov’ero? Che cosa ho fatto per impedirlo?” Ecco, queste domande non ce le poniamo più. La cosa più importante è sembrata liberarsi, doversi liberare da quello che abbiamo chiamato il senso di colpa. E questo è giusto. Spesso il senso di colpa è un peso, è qualche cosa che fa velo, è una vera e propria patologia, quindi è giusto liberarsene. Ma la colpa non è solo senso di colpa, la colpa è la colpa, la colpa è la responsabilità, è la responsabilità attinta a un livello più profondo di coscienza e di esperienza. Quel livello in cui io mi sento responsabile anche di qualche cosa che non ho voluto direttamente ma di cui ho partecipato e che forse addirittura ho voluto senza volerlo: il grande paradosso del male. L’occasione di questa nostra conversazione è l’episodio dei due ragazzi di Novi Ligure. Ecco, sono state dette molte cose, i sociologi, gli psicologi. Eppure alla fine di tutto resta un atto senza spiegazione. Perché se una spiegazione la trovassimo allora non riusciremmo più a capire come mai ragazzi simili, che vivono in famiglie più o meno come quella, che vivono vite più o meno come quella non abbiano fatto la stessa cosa. Loro l’hanno fatto: di qui bisogna partire. E la domanda è: si rendono conto o no? Probabilmente no. La gravità, la spaventosità della cosa sfugge ai responsabili di ciò. Sapranno prendere coscienza di ciò che hanno fatto? Se sapranno prendere coscienza soffriranno terribilmente. Ecco il ritorno alla domanda del signor Canepa. Sappiamo soffrire di fronte al male, dobbiamo soffrire di fronte al male. E’ l’unica via che abbiamo per liberarcene”.
2) A proposito di questo episodio a cui lei anche fa riferimento, il massacro – perché purtroppo pare bisogna chiamarlo – di Novi Ligure si è parlato addirittura di male assoluto. Il male assoluto è quindi qualcosa di cui non riusciamo a recuperare, a decifrare un senso? L’assolutezza verrebbe da questa mancanza di senso?
“Io più che di male assoluto parlerei di paradosso del male. Il male è sempre relativo ed è sempre assoluto. E’ sempre relativo perché il male è fatto da una persona che non se ne rende conto. Il male è fatto da una persona che è portata a farlo a seguito di tutta una serie di condizionamenti, ci sono le circostanze, e quindi il male è relativo: è sempre e soltanto male di una persona. Eppure è anche assoluto, assoluto nel senso che c’è un residuo nel male, nel male che è proprio dei grandi fenomeni che lo esprimono come la guerra ma anche il male che ciascuno di noi fa. Dicevo che c’è un residuo, qualche cosa che resiste alla riconciliazione. Il male una volta fatto è fatto per sempre. Del male non si può venirne fuori semplicemente dimenticandolo o cancellandolo perché appunto questa sua resistenza impedisce che sia possibile lavarsene le mani dimenticandolo o cancellandolo. La logica del male è paradossale. Qualche cosa che si è abbattuto su di noi. Ci capita di farlo senza sapere quello che facciamo. E tuttavia è cosa nostra, è cosa che facciamo noi, che in modo più o meno oscuro noi vogliamo e questo vale in modo particolare per l’episodio di cui stiamo parlando. C’è una sorta di eccesso del male come se il male venisse dall’alto, da una lontananza, da una profondità e questo male tuttavia per quanto trascendente è cosa loro, lo hanno voluto loro. Gli inquirenti non sanno se ci sia stato un movente, pare che sia stato progettato questo fatto – un progetto senza un movente è qualcosa di difficilmente pensabile – però l’essenziale sta altrove: sta nel fatto che qualche cosa di infinitamente più grande della povera vita di questi due ragazzi è stato accolto da loro e loro sono ora costretti a riconoscerlo come cosa loro”.
3) Si è detto sempre a proposito di questa circostanza che si è registrata una mancanza di alfabetizzazione alle emozioni. Alcuni psicoanalisti hanno sollevato questo argomento. I ragazzi non riescono a mediare attraverso le emozioni le proprie pulsioni e quindi arrivano direttamente al gesto: c’è una aderenza, una coincidenza molto preoccupante tra pulsione e gesto. Lei ora ha citato anche mi sembra l’assenza del rimorso nella nostra società: è vero che è una società caratterizzata da questa afasia di emozioni e questa incapacità di rimorso?
“Le emozioni ci sono certamente, non è vero che siamo anestetizzati. Bisogna essere cauti: ritenere che la nostra epoca abbia perduta la capacità di dare voce a ciò che si agita nel profondo del nostro cuore, nella nostra testa, nei nostri nervi significa dimenticare che anche altre epoche hanno avuta questa difficoltà, si sono confrontate con questa difficoltà di dare voce a ciò che si agita nel profondo. Il problema è proprio questo: come fare, quali strutture di senso mediano tra una oscura volontà di dare corpo ai nostri fantasmi e la possibilità reale di fare questo. Certo la religione un tempo ha svolto un’opera di mediazione fondamentale. Non che oggi sia venuta meno ma almeno in parte è venuta meno l’esperienza religiosa diffusa. Di qui la difficoltà a trovare parole, a trovare gesti, a trovare costellazioni di senso che ci aiutino a venire in chiaro di noi stessi. Lo strumento forse più raffinato di cui noi disponiamo sono i libri ma, appunto, leggono i nostri ragazzi? Uno strumento anche raffinato, o che lo sarebbe, è la televisione ma la televisione è capace di fare questo? Io ne dubito. E allora? E allora torniamo alla sua domanda. Che cosa, dove trovare delle forme di mediazione? Io questa domanda la trasformerei in un imperativo: dobbiamo trovare, non resta che ritessere sempre di nuovo questa tela, questa tela linguistica simbolica che è la sola, questa rete che è la sola che davvero ci salva raccogliendo ciò che altrimenti avrebbe una pura forza devastante”.
4) Marcello Di Pietro le chiede: “Molti filosofi hanno spesso parlato di irrazionalità del male. Io penso che la vita sia un succedersi continuo di scelte. Sostenere l’irrazionalità del male non significa annullare la volontà e il libero arbitrio? E’ possibile scegliere il male? Se sì, che cosa spinge l’uomo a questo?”
“Si è vero, un’intera tradizione filosofica ha identificato il male con l’irrazionale. Diceva Socrate: “se tu sapessi davvero quello che stai facendo non faresti il male; il male lo fai perché non sai quello che stai facendo”. Ma anche nel Vangelo c’è un tratto che dice questa inconsapevolezza che avvicina, che identifica il male col fatto di non sapere quello che stiamo facendo: “Signore, perdona loro perché non sanno quello che fanno”. E poi su su nei secoli, grandi secoli della filosofia occidentale ritorna questo tema del male come qualche cosa di irrazionale. La teodicea, l’idea di una giustificazione di Dio di fronte al male, Dio pensato come quel principio, quel fondamento della realtà che deve dare ragione di tutto ciò che è, ecco la teodicea nasce, Leibniz l’ha pensata sulla base della identificazione del male con l’irrazionalità. Il male è necessario come il buio, la tenebra è necessaria alla luce: non ci sarebbe la luce se non ci fosse la tenebra, non ci sarebbe, non potremmo riconoscere un disegno armonico, orientato al bene, disegno di Dio se non ci fosse quel chiaroscuro nel disegno che permette appunto di riconoscere l’intera trama. Altri filosofi però hanno fatto notare che questo è sminuire il peso, la gravità del male. E per ragioni che sono espresse da questa domanda. Il male non è soltanto qualche cosa che è lì, che io non posso se non accettare, in definitiva, nella prospettiva di un bene che lo comprende e lo supera. Il male è un principio attivo. Dire che il male è un principio attivo vuol dire che c’è anche… e questo ci fa orrore. Ma sappiamo quanto sia vero. La volontà di farlo – il male – sapendo che lo si sta facendo, il male fatto per il male, così come il male che si camuffa, il male che si presenta come bene, è una forma di malignità ancora più grave. Cioè sia per il male fatto in nome del male, sia di fronte al male mascherato, camuffato – distruggo, che so io, lo straniero o un certo popolo perché la nazione possa vivere e realizzare il suo destino: questo è il male che si camuffa. C’è una volontà di distruzione qui che impone altre domande rispetto a quelle poste da Socrate o da Leibniz. E quali sono queste altre domande? Quelle che ci lasciano sgomenti di fronte a ciò che la tradizione religiosa ha chiamato il “misterium iniquitatis”, che è tale proprio perché non si lascia spiegare all’interno di un disegno che lo precomprende. Nessun disegno, anche il più meraviglioso, anche quello come diceva Ivan Karamazov che vedesse la vittima e il carnefice alla fine abbracciarsi e dire “tutto quello che è stato era giusto che fosse perché si arrivasse a questo sublime momento di riconciliazione”. Anche un disegno del genere non può assorbire l’urto del male. Ha ragione Ivan Karamazov a dire “ma io dico di no”. E questo mio no delle due l’una: o è asssorbito – e allora dov’è lo scandalo? – oppure non è assorbito e allora quell’armonia, quel disegno, non stanno più in piedi. Ecco l’eccedenza, ecco l’impossibilità di risolvere il male all’interno di una più grande, più alta armonia. Ecco il tragico, la tragedia come genere letterario ma poi l’esperienza del tragico come esperienza che ogni uomo prima o poi fa nella vita è proprio questa: sapere che qualche cosa come una potenza infinitamente più grande di noi sia cosa nostra, cosa che noi vogliamo”.
5) Paolo Maria Ciminelli le chiede: “Qual è la differenza per cui a parità di condizioni esterne, oggettive, uno arriva ad uccidere, ad agire il male come diceva lei poco fa Professore, e il novantanove no? Quell’uno prova una rabbia, un odio, un male quantitativamente più forti oppure ha meno mezzi a disposizione per filtrarli, elaborarli, trasformarli?”
“Effettivamente le cose stanno così. Ciò che sconcerta di fronte a gesti estremi e rari anche se gesti che si ripetono, uccidere i propri genitori – le cronache ci confermano come si tratti di fatti che si ripetono – è questo: perché è toccato a loro fare quello che hanno fatto? Se noi ci interroghiamo, esaminiamo le condizioni esterne sono quelle: famiglie normali, ragazzi normali, questa normalità che non sappiamo bene che cosa sia. Ecco, io non mi preoccuperei tanto di andare alla ricerca delle eventuali ragioni che spieghino questo. Partirei dal fatto che a parità di condizioni alcuni fanno quello che la stragrande maggioranza non fa. Questo dovrebbe dirci qualche cosa che spesso dimentichiamo e cioè che c’è un elemento di libertà, di libertà irriducibile nella scelta che ciascuno fa. Si dirà: ma non sapevano quello che facevano. Certo. Ma dopo che l’hanno fatto la sola chance che hanno è l’anamnesi, il riconoscimento che quello che hanno fatto, l’hanno fatto. Io non credo che né le tecniche di cui disponiamo non possano anche raffinandosi al massimo venire in chiaro della differenza e spiegarci, sulla base di quello che è un determinismo in definitiva, spiegarci perché gli uni sì e gli altri no. Possiamo piuttosto interrogarci su quello che segue, su quello che seguirà: un lento processo dolorosissimo di presa di coscienza. Questo è il vero problema. E’ accaduto. La ragione è che non ce n’è nessuna. La ragione è che loro hanno scelto di farlo ed altri non hanno scelto di farlo. Naturalmente questo scegliere non deve essere inteso nel senso banale. Questo scegliere affonda in una profondità dove la responsabilità è parola povera. Bisogna forse usarne altre. La parola colpa è già parola più ricca. Qual è la differenza tra responsabilità e colpa? La responsabilità è quella di cui un giudice, un tribunale mi può accusare perché presuppone una mia intenzione precisa. La colpa invece è qualche cosa di più profondo. È qualche cosa che io ho compiuto senza rendermi conto di quello che facevo e tuttavia l’ho fatto. Edipo. Ecco perché qui entriamo senza riserve nel dominio del tragico. Nessun tribunale avrebbe potuto accusare Edipo di aver ucciso suo padre, non sapeva mica che era suo padre, lui era figlio di un re, era nel suo diritto tagliare la gola a un tanghero che gli attraversava la strada, era nel suo diritto secondo il diritto arcaico dei greci. E tuttavia Edipo lentamente, dolorosamente, si rende conto che quello che ha fatto non volendolo in realtà l’ha fatto volendolo. Ben prima di Freud i tragici ci insegnano che la colpa è qualche cosa di ambiguo, di paradossale ma di profondamente umano e l’uomo deve partire da lì”.
6) Annamaria Zollo vuole sapere: “Come tutti in Italia presumo abbiamo discusso in classe della tragedia di Novi Ligure ma soprattutto del male dentro di noi. Qualche alunno più sincero ha ammesso di aver provato il desiderio di uccidere ma di essersene subito vergognato e di volersi nascondere a sé stesso dopo. Mi hanno quindi chiesto che cos’è il male. Per rispondere loro dovrei saperlo io per prima, ma quando ci provo il cor si spaura, di fronte alla parte profonda, abissale eppure sembra così superficiale del nostro animo. Professor Givone chiedo a lei di rispondere, perché io possa rispondere ai miei ragazzi, figli ed alunni”.
“Davvero è questa la domanda? Che cos’è il male. Ma siamo sicuri di non sapere esattamente che cos’è il male? Anche in assenza di una definizione che ci dica concettualmente che cos’è o, peggio ancora, pretenda di risolvere il problema, l’enigma del male. Noi lo sappiamo. Lo sappiamo perché lo facciamo e perché lo patiamo. Diceva Pascal irridendo Cartesio: altro che cogito ergo sum, faccio il male e lo patisco il male, dunque sono. Non c’è prova di esistenza più certa, più inconfutabile di questa. Ho mal di denti non c’è santo che tenga, si ha un bel dire che la vita è sogno, che mi illudo, no: ho mal di denti, figuriamoci quando si tratta di ben altro male, sia che io lo faccia, sia che io lo patisca. Questo per dire che il male sappiamo che cos’è. Sappiamo proprio nel senso di sapere, quel sapere che è tutt’uno col sentire. È qualche cosa di talmente intimo a noi – il male – che dovremmo usare la formula di Sant’Agostino, la formula da lui usata per il bene, per Dio: intimior intimo meo, il male è ancora più intimo a me di quanto io non lo sia a me stesso. Ecco che cos’è il male. Ma la domanda che più dà da pensare non è questa, è un’altra. Anche qui è proprio Sant’Agostino che ci aiuta. Non è quella che chiede che cosa sia il male ma quella che chiede da dove venga il male. Infatti lo abbiamo detto e credo valga la pena di ripeterlo: l’esperienza che uno fa, sia che lo faccia il male che lo patisca è di essere di fronte ad una forza che eccede i limiti, la dimensione nella quale vive. Per questo il male è stato spesso identificato con il demonio, con il demoniaco, o comunquecon una realtà trascendente. È troppo più grande dell’uomo. La professoressa con i suoi ragazzi si è interrogata e uno di questi ragazzi giustamente, con grande sincerità ha detto ma come, anch’io sono visitato da quei desideri, da quelle pulsioni, li si chiami come si vuole. Si tratta per l’appunto di qualche cosa che viene, sembrerebbe venire da fuori di noi e ci visita. È una verità zoppa, una verità dimitiata quella che si limita ad affermare o la trascendenza del male – per cui noi saremmo semplicemente dei burattini nella mani di quel grande burattinaio che è il demonio, che è la forza demoniaca che ci possiede e così via – ma dimitiata è anche la verità di chi dice ma il male in fondo è cosa dell’uomo, si tratta liberandosi dei sensi di colpa di capire esattamente quali sono le dinamiche che presiedono alla sua manifestazione, il male in realtà non è il male, è un fatto fisico, addirittura chimico, una chimica tutta interiore. C’è del vero anche in questa verità dimidiata ma per l’appunto è una verità zoppa. Bisogna dire, e non mi stancherò di insistere su questo punto che il male è una potenza eccessiva che ci trascende e nello stesso tempo è cosa nostra: il paradosso”.
7) Guido Perazzi invece è interessato a un altro aspetto e le chiede: “La politica dell’amicizia non è ancora capace di sostituire la politica dell’inimicizia, della polemica e della guerra, che è ancora il motore di tutte le cose e il perno, quindi il non dialogo e il non rispetto degli altri. Professor Givone, non è questo il male più determinante di tutti i mali, che peraltro la classe dirigente non sembra in grado di cogliere e quindi di risolvere?”
“Sono anche disposto a concedere che la guerra sia il motore di tutte le cose cioè che le cose siano animate da una conflittualità profonda che sembra irriducibile. Sono anche disposto a concedere che l’inimicizia cioè pensare un rapporto fra gli uomini in termini di amico/nemico Però quando si tende a vedere il male, a collocare il male fuori di noi e a identificarlo nelle forme della nostra vita cioè in quelle forme dentro le quali noi viviamo, quando il male lo si identifica con le strutture della società e può essere per l’appunto la società stessa, può essere la scuola, può essere la famiglia, ecco io qui ci vedo una tentazione ricorrente nella cultura moderna e contemporanea, è cosa davvero nostra questa, nostra di noi contemporanei. La tentazione di liberarci di ciò che è nostro addossandolo – il male per l’appunto – a qualche cosa che nostro non è o che è nostro ma solo in modo tangenziale: la società, la scuola, la famiglia. Io vedo del rousseauvismo. Rousseau, che resta quel grande pensatore che ci ha insegnato tante cose però è colui che come nessun altro seduce, tenta, cioè ci seduce e ci tenta nel senso di una restituzione a una improbabile innocenza, addossando la colpa ad altri o ad altro”.
8) Franceschina Cocinto invece ripropone un tema che abbraccia i due argomenti forse centrali in questa discussione: passioni e ragione. E le chiede: “Le passioni senza ragione portano al male della dittatura mentre la ragione senza passioni porta al male dell’indifferenza. È possibile sperare di poter controllare il male, limitando la libertà, regolando gli istinti primitivi e le passioni mediante la ragione?”
“Io qui farei il professore. Forse l’ho fatto finora, e mi dispiace, nel senso che sono necessari alcuni chiarimenti, alcune precisazioni terminologiche. Quando si dice “limitare la libertà” si dice qualche cosa di inesatto: la libertà è la libertà. La libertà o è libertà di fare quello che si vuole o non è. Una libertà limitata è qualche cosa di contraddittorio. Con questo non voglio dire che possiamo fare quello che vogliamo, cioè che è lecito fare quello che vogliamo. No: sto dicendo che è questione non tanto di libertà quanto di liceità. Certo che noi dobbiamo definire ciò che è lecito e ciò che non è lecito, fin dove mi posso spingere e fin dove no. Ma questo non ha a che fare propriamente con la libertà: libero io infatti di trasgredire quella legge che dice che cosa è lecito e che cosa non è lecito. Una precisazione: è chiaro che si può parlare del male solo se si parla anche della libertà. A questo proposito va detto qualche cosa che può sembrare strano ma che va detto: la libertà, contrariamente a quello che si crede non è un valore di per sé. La libertà è sempre più che un valore o meno che un valore. Meno che un valore: infatti io posso negare la libertà solo con un gesto di libertà, solo se l’assumo, la faccio mia. Il totalitarismo è questo: la negazione della libertà degli altri da parte di qualcuno che l’attribuisce a sé. Dunque se la libertà è lo strumento di un’operazione tanto negativa non si vede come possa essere un valore. Però è più che un valore, perché qualsiasi valore, anche un valore più universalmente condiviso, un valore su cui tutti ci si metta d’accordo – essere solidali gli uni con gli altri, distribuire meglio le ricchezze e così via – qualsiasi valore, nel momento in cui diventa oggetto di una imposizione, nel momento in cui io sono obbligato a fare quello che pure è bene: bene non è più. Nel momento in cui io tolgo la libertà e obbligo qualcuno a fare quello che io ritengo sia bene è finita: non c’è più bene, non c’è più valore. Ecco che cos’è la libertà. È questo principio, come hanno detto filosofi che hanno riflettuto su questo tema, è ciò che sta all’inizio e non è preceduto da nulla. E in questo senso non può essere limitata”.
9) Anche Angela Senno insiste su questo tema della libertà, del libero arbitrio e le chiede: “Il mondo è tanto ricco perché contiene il demonio, fintanto che però gli teniamo un piede sul collo. Così diceva William James. Le domando: limitarsi a reprimere il male, invece di ricercarne insieme le radici profonde, non è inutile e persino pericoloso per la convivenza civile?”
“Se è vero che la libertà o è illimitata, o è assoluta, o non è, non è vero che il male non debba essere represso. Il male deve essere represso. Il “no, non deve essere” è l’imperativo a partire dal quale noi riconosciamo il male e tanto più il male è grave, è orribile, è intollerabile tanto più forte deve suonare questo nostro “no”, questa repressione del male. Ciò non significa che la repressione sia tutto. Certo dobbiamo educarci alla libertà. Educarci alla libertà significa educarci a scegliere tra bene e male e questa è la cosa più difficile. Perché che libertà è quella che non si scontra con la realtà negativa del male, che libertà è quella che è semplicemente un aspetto più o meno piacevole della propria personalità. La libertà è tormentosa, la libertà è qualche cosa… chi non ricorda l’apologo del grande inquisitore di Dostoevskij, è qualche cosa di cui gli uomini non vogliono sapere perché non c’è niente di più doloroso che l’esperienza della libertà. Gli uomini ne farebbero volentieri a meno, infatti ogni volta che qualcuno gliela evita – la libertà, nel senso dell’incontro, dello scontro, della prova, della verifica della scelta, della esperienza del bene e del male, perché questa è la libertà ebbene tutto ciò l’uomo, ogni volta che incontra qualcuno che gli evita questa prova gli dà retta, gli va dietro. E come diceva appunto il grande inquisitore se è pronto a mettere sottosopra il mondo però è altrettanto pronto, ancora più in fretta, a inservilirsi, dopo aver fatto la rivoluzione, a mettere a disposizione la propria libertà di chi la gestisce a suo nome”.
10) Daniela Semenzato pone un’altra questione che è quella dei valori e della trasmissione dei valori e dice: “La mia generazione non è stata abbastanza brava a trasmettere ai figli in certi casi non ha voluto farlo il sapere che legava la tradizione del passato, la storia privata e pubblica, alla conquista del futuro. Per i figli quel sapere, per noi così prezioso, si è svalutato in quanto la tecnologia ha sovvertito i rapporti di forza tra le generazioni. Mi sembra che la frattura con i nostri figli sia più tragica perché priva di contestazione, di possibilità di trovare articolazione attraverso il linguaggio. Non è anche questa possibilità che permette di segnare il confine tra il bene e il male?”
“Indubbiamente il nostro mondo conosce rispetto alla tradizione, ai valori che la tradizione trasmetterebbe, una frattura come in nessun’altra epoca storica. Vero è anche che i processi di trasformazione, governati dalla tecnologia, sono tali da mettere nelle mani dei nostri figli degli strumenti che noi non abbiamo e quindi è successo qualche cosa che non era mai successo prima. Le generazioni giovani sanno più di quanto non sappiano i padri e tutto questo, naturalmente, ci mette in conflitto gli uni con gli altri. Ma intanto io mi chiedo: siamo sicuri che anche in epoche passate non sia stato precisamente il conflitto a mettere in moto, a governare, gli stessi rapporti tra le generazioni e a permettere alle generazioni che vengono di emanciparsi dalle generazioni da cui provengono? Siamo sicuri che non ci sia comunque qualcosa di positivo in tutto ciò? Pensare alla tradizione come una semplice cinghia di trasmissione, di valori se non immutabili certo codificati in modo rigido, pensare la tradizione in questo modo significa privilegiare quelli che sono dei mondi statici e chiusi rispetto a quelli che sono, come in fondo il nostro, dei mondi invece dinamici e aperti. Certo che questo dinamismo e questa apertura fanno male, creano una conflittualità permanente. Anzi, qualche cosa di più che viene messo in luce giustamente da questa domanda: creano l’incomunicabilità, l’impossibilità, l’incapacità di comunicare tra le generazioni. Tutto questo è molto vero ma io insisto: un mondo dinamico e aperto è forse preferibile a un mondo di valori condivisi, che può condividere questi valori in nome di una staticità e di una inerzia che non hanno nessun valore morale, che non hanno nessuna forza liberante. I greci hanno inventato la tragedia proprio per uscire dalla staticità di un mondo che riteneva di poter trasmettere i propri valori ammortizzando il conflitto fra le generazioni. È così perché è così, dice il mito, è così perché è sempre stato così, fai questo perché questo è stato fatto dal fondatore della città e così ha voluto che fosse. Questa è una concezione violenta, autoritaria del mito, del mito come contenitore dei valori e di quella tradizione che, interpretando il mito li trasmette i valori. Interviene la tragedia a dire: “ma perché, non mi sta mica bene, perché devo fare quello che è sempre stato fatto solo perché è stato fatto all’origine? È giusto, non è giusto?” Introduco una categoria, quella di giustizia, che confligge, entra in collisione con la categoria di autorità. Questo modello per cui il conflitto prevale sulla trasmissione dei valori è un modello positivo. Certo comporta fatica, dolore, lacerazioni talvolta incomponibili, la tragedia non fa che parlarci di queste lacerazioni incomponibili ma di lì bisogna passare”.
11) L’ultima domanda, di Agnese Valerio, solleva una questione più di ordine sociologico. Agnese Valerio le chiede: “Anche in episodi recenti si è vista la tendenza a individuare il male nel diverso. Perché nell’immaginario collettivo dei film di fantascienza, la tragedia di Novi Ligure, l’alieno, l’immigrato, lo straniero uccide e violenta?”
“Perché questo tranquillizza, mette a posto la nostra coscienza e soprattutto ci dà un’idea – e noi sappiamo quanto sia falsa questa idea – di vivere nel migliore dei mondi possibili. Chi fa il male, chi violenta è lo straniero, è sempre l’altro, è colui che è proveniente da un paese che non è il nostro. Certo irrompe ma è pur sempre – questa irruzione – un fatto che non appartiene alla normalità. Sappiamo che non è così. Appunto e gli episodi che sono citati dimostrano primo che immediatamente ricorriamo a questa immagine, a questo modello di spiegazione, secondo che questo modello di spiegazione è fasullo. Ora però le cose sono un po’ più complicate rispetto a quello che dicevo prima e cioè non abbiamo a che fare soltanto con un bisogno di rassicurazione: la dinamica propria del male è quella che coinvolge la figura dello straniero. Se il male è in quanto tale irruzione da una trascendenza o da una lontananza o comunque come tale vissuto da chi lo fa. Il fatto è che il male è nello stesso tempo fatto da chi lo fa, scelto, voluto, da chi ha scelto, voluto di farlo ecco come lo straniero siamo noi. Questo è l’insegnamento che se ne ricava ciascuno di noi pur restando sé stesso è straniero rispetto a sé. È la dialettica del male, è la sua tragica paradossalità, così la chiamerei”.