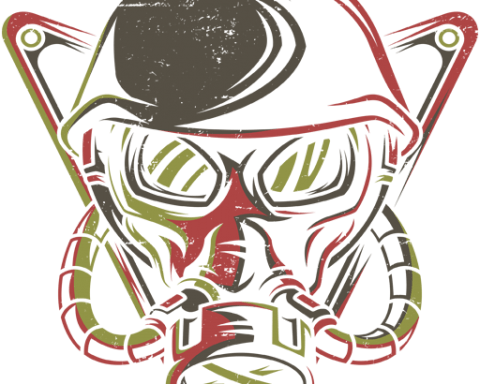di franc’O’brain
"Hello darkness, my old friend… I’ve come to talk to you again."
(Simon and Garfunkel: The Sound of Silence)
Svegliarsi ogni giorno sullo stesso pianeta e tra la stessa gente: una noia incommensurabile. Al di là del muretto di pietra, rumori di cucina e fumo denso, e una signora che rimesta il brodo bollente; la radio propaga clamori di guerra civile, pronunciamenti militari, notizie di movimenti di truppe nelle caserme e alle frontiere… la solita solfa, insomma. Ma quel giorno era in qualche modo diverso. E lo era per colpa – o merito – di un sogno.
Il giovane Nicu Jota sognò di trovarsi in un cortile perfettamente identico a quello dei suoi genitori. Faceva un caldo insostenibile. Accanto alla casa cresceva un ippocastano, ma non gettava quasi ombra. Nicu avanzò, tritando la ghiaia, fino alla fontanella. Bevve (l’acqua era schifosamente tiepida e sapeva di ferro) e si forbì la bocca col dorso di una mano, mentre con l’altra si riparava gli occhi. Troppa luce. Doveva essere mezzogiorno o giù di lì: non precisamente la sua ora.
Due ragazze gli vennero incontro. Nicu trasalì: non solo il cortile era identico a quello che lui conosceva tanto bene (e che denominavano pomposamente "il Giardino"), ma le due ragazze gli rammentavano Sina e Vilma, ovvero le sue sorelline. Pupattole anoressiche che indossavano vestiti appena accennati. Sina era praticamente nuda: i peli della sua yoni venivano mossi da una leggera, insignificante brezza – pessima imitazione dello zeffiro.
Nicu Jota non dubitò neppure un istante che lo avessero riconosciuto. Inforcando gli occhiali da sole per proteggersi dal sole assassino, andò loro incontro. «Volete fare una passeggiata?» chiese.
Ma le sorelle gli risero in faccia. «Soltanto un cieco potrebbe scambiarti per Nicu. Lui è tanto più bello e tanto più gentile di te.»
«Nicu sono io!» protestò questi. Ed era sicuro di esserlo per davvero. C’era tuttavia qualcosa che gli sfuggiva, come se il nastro dei ricordi si fosse spezzato. Su lui e sulla sua famiglia aleggiava un presentimento di maledizione. Ogni famiglia è segnata da storie grottesche di destini incrociati. Qual era la sua storia? Quale il suo destino?
Accorgendosi che le pupattole lo guardavano con ingordigia, leggermente strabiche e con pupille opalescenti, avvertì una lama fredda penetrargli le scapole. «Chi è vostro fratello, dunque, se non io?» inquisì.
«Nicu», risposero all’unisono Sina e Vilma. «Così lo hanno battezzato mamma e papà e così lui si chiama. Oh, possa vivere a lungo e felice! Tu come ti permetti di spacciarti per lui?»
Nicu Jota si guardò intorno, cercando una via d’uscita dalla dimensione dell’incubo. In quella, inopinabilmente, le ragazze scattarono in avanti e, mentre l’una lo teneva stretto, l’altra lo morse sul collo.
«Cosa…?»
Si sentì ronzare le orecchie, la testa, l’anima. Quel morso fu come un bacio, un bacio straordinariamente possessivo che gli causò un vibrare ininterrotto delle membra, un pulsare dei muscoli facciali e ventrali. Ci fu un istante -un unico, breve istante – in cui intuì la terribile verità: era irrimediabilmente perduto in un dedalo immobile; un’anima vagolante nelle anse del tempo e degli spazi circolari. Poi il nastro tornò a spezzarsi e il pensiero svanì. Rimase l’incubo.
Si rese conto che le sue sorelle avevano una pelle di carta velina ed emanavano un forte profumo di anice. "Ma non avrei dovuto già saperlo?" si disse. Intanto i suoi occhi rotevano come quelli di un cavallo impazzito, mettendo a fuoco il greto di un fiume senz’acqua, geometrie di tratturi deserti e, in alto sopra ogni cosa, il castello del conte Vlad, ricostruito a beneficio di turisti tedeschi e americani.
Quando i denti di Vilma si staccarono dalla sua carne con un lugubre risucchio, Nicu dovette aggrapparsi al muretto, per non cadere svenuto. "Che sogno di merda!" pensò. Nessuno sembrava aver notato l’accaduto. Del resto, nel cortile non c’era nessun altro a parte un cagnaccio che crepava di malinconia su ciuffi di paglia chiara, dietro siepi spinose.
Nicu chiuse gli occhi, li riaprì. Le sorelle stavano a guardarlo con aperta ostilità. Ghignavano senza spiccicare una sola sillaba, tutte reginette di ghiaccio. Di solito avevano qualche ingiuria parata (uscivano sempre vincitrici da ogni litigio… oh, le interminabili farse domestiche!); le parole "bastard" e "stronzo" erano eternamente sulla punta della loro lingua. Ma adesso quel protratto silenzio, accompagnato da sguardi di ossidiana, faceva rabbrividire Nicu fino al midollo delle ossa. "Davvero mi credono un estraneo?" si domandò. "Devo vederci più chiaro" decise.
Mentre rifletteva in questo modo, si trovò in un identico cortile-giardino, che gli appariva alquanto bislacco, come se qualcuno avesse rimosso i singoli elementi che lo componevano per risistemarli poi alla bell’e meglio. Ma poteva anche trattarsi di un’illusione ottica dovuta a tutta quella luce. Nicu Jota era abituato ad andare a letto alle cinque del mattino e a risvegliarsi alle sei di sera. No, quella non era, decisamente, la sua ora. C’era inoltre una calura opprimente che gli faceva sembrare di aver cacciato la testa in un mare di zucchero filato.
Il collo gli bruciava; se lo toccò, poi guardò il dito macchiato di rosso. La mascella gli ricascò sul petto. Gemendo, mosse qualche passo su gambe altamente insicure. Il suo corpo assunse un’angolazione tale da fare ammutolire chiunque gli si fosse trovato davanti. Ma nel Giardino c’erano solo il vecchio cane e, poco più in là, le due sorelle che ballavano e lesbicavano.
Un sogno?
Poiché nell’ultimo periodo aveva dormito poco, stava vivendo uno sballo a livello cerebrale. Ma uno sballo forte: uno Sballo. E senza l’ausilio di oppiati. Faceva spesso dei sogni incredibili, anche a occhi aperti. Da tempo non raggiungeva più la fase REM. Si accontentava di due-tre ore di pennichella a notte (o, meglio, a giorno), e ciò bastava per riempirlo di visioni. Si trovava in una condizione di semi-allucinazione permanente; i suoi pensieri correvano per lande indescrivibili mai esplorate prima. "E sarà meglio che questo giorno lo trascorro a letto, sennò chissà che cosa succede al mio cuore, al mio cervello, a tutto! (Può un uomo scoppiare? Voglio dire: esplodere, letteralmente? Esplodere come una nova, irrogando il mondo circostante del suo sangue e dei corvi neri della Notte di Walpurga della sua anima?)"
Certo, lo "sballo" era un’esperienza come tante altre, ma meglio non ripeterla troppo spesso. Si rammentò di quella volta in cui, quindicenne, sdraiato sul lettino della sua stanza sotto-il-tetto, volle fare l’esperimento di distaccare la mente dal corpo. Ad un tratto aveva avuto l’impressione di sollevarsi a mezz’aria… Dopo quei pochi secondi di "levitazione", il suo cuore aveva cominciato a battere all’impazzata. Era stata un’esperienza-limite, una delle prime della sua vita: il tentativo di mettere alla prova il proprio essere.
Ora, con gli occhi e il cervello pieni di colla, prese di mira l’ingresso della casa, la cui ombra lo attirava, invitante. Nascondersi in quell’anfratto: ecco il suo più grande desiderio. Cercò di indirizzarvisi, ma le gambe crollarono sotto il corpo. Girò su se stesso, cadde in ginocchio. Pregare minacciare respingere, un implorare con la bocca muta… Lievi nuvole di vapore gli fuoruscirono dalle labbra. Finalmente recuperò le
energie residue e puntò sull’ingresso.
«Nicu! Ni-CU!»
Vilma aveva uno strano modo di chiamarlo, pronunciando la seconda sillaba del suo nome di qualche ottava più alta. Ma, essendo lei la sua adorata sorellina, poteva permettersi quel tono.
Nicu si arrestò e, abbracciando l’ippocastano, chiese, pieno di speranza: «Ah, ora mi riconoscete?» Si girò, ma non vide le due da nessuna parte. Allora, al colmo della disperazione, urlò: «In nome di nostra madre che vi ha dato la vita, in nome del cielo! Per la salvezza della vostra anima, vi supplico di dire la verità!»
Non gli giunse risposta. Al di là del muretto, richiami vaghi e urla stancanti passavano veloci nell’aria. La radio dei vicini sbatacchiava:
All I need is a rhythm devine, viva la musica say you’ll be mine…
Nicu Jota emise un sibilo gelido, mentre al di sopra del cortile sfrecciavano rondini controvento. Se stringeva gli occhi, poteva distinguere le propaggini di cemento della periferia di Bucarest – gli sconfinati slums di Dead City -, con la cappa nebbiosa sopra i grattacieli. (Dannati di questa Terra, unitevi!) E, a meno di mezzo chilometro di distanza, un Caterpillar abbandonato. Paese di sassi e miseria… Odiava quel posto, ma non era capace di distaccarsene, neppure durante le fasi oniriche.
I contenuti di un sogno sono il prodotto della civiltà: rispecchano le influenze culturali del tempo e del luogo. Per noi, figli del nostro tempo, questo significa: BSE, afta, AIDS, buco d’ozono e guerre varie. E, per quanto concerne segnatamente la Romania: povertà e corruzione. Il padre di Nicu era stato un "soldato di partito“: ecco come mai la famiglia Jota era in possesso di quella dacia.
Nicu osservò la facciata, che presentava tutte le palpebre chiuse; quindi vi si lanciò contro. L’interno era al buio: lux est luxus. Soltanto una tenue luminiscenza proveniva dal piano superiore. Divorò gli scalini a tre alla volta. Gli occhiali scuri gli si appannarono e dovette fermarsi per toglierseli. Giunto in cima, si ritrovò dentro una stanza oblunga: un ambiente poco pretenzioso, una sorta di canile con un’unica lampadina che penzolava dal soffitto. Le serrande erano chiuse, la candela Osram accesa.
La stanza sotto-il-tetto odorava di candeggina e detersivi. Niente di strano, dato che fungeva anche da lavanderia. A un’estremità era piazzata la lavatrice: più che un elettrodomestico, era un Moloch che borbottava monotamente. Due ragazze erano affaccendate con la biancheria e ridevano. All’altra estremità c’era un letto e, sul letto, un giovane sui vent’anni.
Inoperoso come sempre. Un vero pelandrone, l’onta della famiglia. Nicu Jota cercò per lui delle giustificazioni. I suoi genitori tenevano in casa solo due libri: la Bibbia e l’autobiografia di Ceausescu. Ecco perché quel ventenne era diventato così. Ecco perché aveva scelto il letto come sua residenza perenne. Ma in fondo era un bravo ragazzo.
Si trattava del suo avatar? Del suo clone? Un clone è un gemello con un identico codice genetico, ma i due non sono necessariamente la stessa persona.
Sebbene la stanza fosse iperriscaldata, Nicu si sentì tremare per il freddo. Vide Sina issarsi una cesta sulla testa, in equilibrio, mentre Vilma, china su una bagnarola, canticchiava allegramente. Il giovane sotto le coperte osservava le sorelle fra mille sbadigli. Evidentemente si era appena destato. Quando si piegò su un fianco per prendere un bicchiere che conteneva dell’acqua straclorata, Nicu si accorse che aveva sul collo due buchi vistosi.
In quel momento Vilma si rivolse al giovane:
«Sei così triste, Nicu! Che cosa hai sognato?»
«Ho sognato di trovarmi in un giardino e che voi due non mi riconoscevate più. Anzi: vi comportavate proprio da streghette!» Il poltrone si toccò i buchi, poi guardò il dito macchiato di rosso, se lo portò alla bocca e – «Mmm…» -assaporò il sangue. «Dicevate che non ero vostro fratello! Dopo sono entrato in casa e ho scoperto un altro Nicu che dormiva sul mio letto.»
Nicu, che aveva seguito quella discussione, non poté trattenersi dall’intromettersi.
«Sto cercando Nicu Jota», dichiarò. «Sei tu?»
Il giovane deviò lo sguardo su di lui. Gettò a terra le coperte e si sollevò con ossa che crocchiavano. Appariva stanco, schiantato. I suoi capelli – simili alla cresta di un upupa -sfioravano il soffitto basso e affumicato dagli anni. Avanzò nella polvere che danzava follemente e venne a fermarsi a pochi centimentri da lui.
A questo punto, sotto i miasmi della candeggina e dei detersivi, Nicu percepì un altro odore, un odore diverso: lo stesso che doveva regnare nella mitica palestra di Amor. "Che succede in questa casa?" si disse; e, alla copia di se stesso: «Non sei tu… non sei me. Sei soltanto la mia copia».
«Tu non ci credi, credo, e non lo vedi, vedo», replicò il giovane. Quindi mutò repentinamente tono ed espressione. «Faccia da oboe, culo di merda, piscialetto, appendipanni, MacDonaldiano, falso saccente!» prese a insultarlo, sotto gli sguardi tifosi e lascivi delle sorelle.
«Dorminpiedi, Mister I’m-looking-so-good, segaiolo, imperialista, muso di cane!» gli vennero in soccorso queste.
Per la durata di un battito di ciglia, a Nicu mancò il respiro. Ma non poteva lasciarsi sopraffare, non poteva farsi asservire in quel modo. Doveva rimpossessarsi, con calma, con affabilità, del suo piccolo reame. Indicando Sina e Vilma, chiese: «Loro… che cosa ci fanno qui?»
«Non lo vedi? Lavano i panni e mi tengono alto il morale.»
«E tu perché stai rinchiuso?»
«La luce mi fa male agli occhi», rispose il giovane. «Eppoi questa terra ha artigli micidiali. È difficile sopravvivere, là fuori.»
La lampadina si spense e si riaccese: uno scompenso elettrico, fenomeno normalissimo da quelle parti. Nicu restò a fronteggiare la copia di se stesso. Il pelandrone aveva occhi innaturalmente rossi, o almeno così gli sembrò. Lui stesso sapeva di presentare un aspetto spaventoso: barba di tre giorni, capelli lunghi e selvaggi, bocca dalle labbra screpolate che si rifiutava di aprirsi se non per emettere sentenze irreali, ecc. Ma doveva tornare a tutti i costi ad occupare quello che considerava il suo posto legittimo.
Volse la testa verso le pupe. Emaciate e silenti, assistevano alla scena grattandosi distrattamente i riccioli del pube.
«Giù gli occhi dalle mie sorelline!» scattò allora Nicu Due, con voce affilata. Probabilmente credeva di avere un diritto di prelazione sulle ragazze.
«Quelle sono le mie sorelline», proclamò Nicu. Poi, lottando contro gli stimoli della ragione, che lo inducevano a risvegliarsi, ebbe un sorriso d’intesa per il suo gemello e, ammiccando, gli puntò un dito sulle costole.
Il gesto sembrò far rinsavire di colpo Nicu Due. Lasciandosi andare a un abbraccio (Nicu si sentì accapponare la pelle), Nicu Due disse: «Dunque non era un sogno! Eccoti tornato, Nicu Jota!»
Nicu Jota si destò. Un filo di bava bagnava il guanciale. Si sentiva decisamente grullo, e riuscì ad abbandonare la brughiera dell’oblio solo dopo aver risalito un lungo, lungo declivio. Le sorelle investigarono: «Che cosa hai sognato, Nicu? Sei così triste!»
«Ho sognato di trovarmi nel giardino e…» Si interruppe per toccarsi i buchi che scoprì di avere sul collo. Poi studiò perplesso il dito sporco di rosso. «Mi sono risvegliato in uno strano posto», aggiunse.
«Che cosa vuoi dire?»
Alzò lo sguardo, ma le ragazze non c’erano più. Forse, magre com’erano, erano passate attraverso le intercapedini… Inforcò gli occhiali da sole, si sollevò dal suo letto di morte e andò a guardare dagli spiragli delle persiane. Le vide correre in mezzo alle ortiche, entrambe nude: come ninfe, come naiadi. Tornò a girarsi e… scorse qualcuno sul suo letto.
«Speravo ardentemente che tu venissi, Nicu Jota!» trasmise il giovane, stiracchiandosi sotto le coperte.
Nicu Jota lo scrutò disorientato. Per l’arco di un secondo capì di essere intrappolato in qualche dilatazione einsteiniana della dimensione temporale. Prigioniero di una situazione che si rimandava all’infinito. Ma non sarebbe servito a nulla tentare di opporvisi: non c’era altra esistenza che quella.
Il giovane continuava a guardarlo; la contentezza gli bruciava le pupille con gli occhi di mille soli. L’evidente goffaggine che contraddistingueva ogni suo gesto sanciva una gioventù incompiuta e inutile. Non era che un guitto poco talentuoso, una scimmietta vegetante nella dimora paterna.
Nicu Jota non gli replicò alcunché. Tornò a spiare dalle persiane. Fuori era più caldo e più soffoco che mai. Quelle prugnette delle sue consanguinee si mordevano a vicenda la gola: il loro trastullo preferito. Il cagnone se ne stava buttato come sempre sull’erba rinsecchita. Sull’orizzonte sempre più vicino si innalzavano nuovi casamenti popolari, ennesime sedi di illusioni e speranze irrancidite. Sul muretto del cortile antistante qualcuno aveva scritto:
RED ARMY GO HOME.
Il sole cominciava a declinare. Finalmente! Una comitiva di turisti, di quelle che Nicu dileggiava spesso e volentieri, si arrampicava su per un viottolo fino al famigerato castello. La loro scalata sembrava simboleggiare lo stesso percorso doloroso dell’umanità. Dal castello proveniva un’esalazione misteriosa con cui la gente dei paraggi non si sentiva di competere e che gli stranieri non erano mai veramente in grado di percepire. Ma il giorno si avviava alla conclusione: presto sarebbe scoccata l’ora in cui Nicu fosse tornato sereno, l’ora in cui si ricompattava la sua personalità dissociata.
"Domani è un altro giorno e nella clessidra non scorre sabbia, ma sangue miscelato a una sostanza indefinibile: piccole cellule microscopiche, ministrutture; larve di insetti invisibili."
Intuì che sarebbe stata una notte lunga, molto più lunga del solstizio d’inverno.