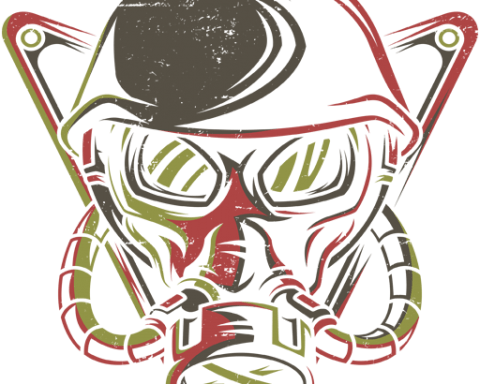di Emilio Lledó
1. Professor Lledó, ritiene sia necessario, per meglio comprendre la filosofia in generale, e la filosofia dell’antica Grecia in particolare, studiare in maniera approfondita la terminologia filosofica greca antica?
Il problema è molto interessante, perché in effetti il pensiero greco è all’origine del pensiero occidentale, e il lessico filosofico dei Greci ha influito in modo decisivo sullo sviluppo del vocabolario filosofico posteriore. Tuttavia, questo vocabolario astratto della filosofia ha avuto origine in momenti determinati e concreti della storia della società greca. Qualsiasi evoluzione, qualsiasi sviluppo posteriore di questi concetti è sempre stato influenzato e condizionato dall’origine concreta, e dalla società che li ha inventati, scoperti e studiati.
Ora, il vocabolario astratto, filosofico dei Greci era radicato e trovava alimento nei bisogni di una società determinata e concreta. Per questo motivo credo sia molto importante studiare la terminologia filosofica dei Greci a partire dal momento in cui tale terminologia costituiva ancora un linguaggio vivo, ed era diretta espressione dei bisogni concreti di una società che cercava di instaurare un rapporto concettuale con il mondo, per dominarlo e renderlo comunicabile. Infatti le parole greche classiche, i termini chiave della cultura filosofica greca, hanno avuto un’evoluzione nel corso della quale ci si è dimenticati della loro vera origine, viva e reale.
2. Quando si parla della lingua greca antica ci si riferisce a essa come a una lingua morta. Ma non è vero forse che gran parte, non solo delle parole, ma anche dei concetti delle lingue moderne, è fortemente condizionata dai concetti e dai termini della lingua greca?
Effettivamente molti dei concetti moderni sono condizionati da termini filosofici Greci antichi, ma è proprio questo condizionamento che rende così importante ripensare questi termini, riacquisirli all’interno delle nostre lingue a partire dalle prospettive della modernità, e vedere se tale terminologia filosofica pulsa, vive, ha ancora senso in quell’uso quotidiano così confuso, contraddittorio e problematico che se ne fa all’interno della nostra società.
Pertanto, quando si pensa a molti dei termini chiave della cultura filosofica greca, non bisogna farlo con un approccio archeologico, come se si trattasse di parole che esprimono esclusivamente concetti relativi a spazi e ambiti culturali lontani. Occorre invece accostarsi a questi termini come a parole che posseggono, per così dire, vita linguistica, e che hanno una eco, che possono dialogare con i bisogni, con i problemi e con i comportamenti della nostra vita e della nostra contemporaneità.
3. Che cosa vuol dire esattamente il termine greco eudaimonia?
Il termine eudaimonia si potrebbe tradurre, con una certa approssimazione, con la parola «felicità». Tuttavia il campo semantico di tale termine è molto più ampio. Esso è molto importante, per varie ragioni. La prima di queste è legata al fatto che all’inizio dell’Etica Nicomachea di Aristotele, quello che forse è il primo grande libro sull’etica greca, sulla struttura del comportamento umano, si dice che la natura stessa degli esseri umani porta questi a cercare il bene, a cercare ciò che a loro è utile, e che non distrugge la loro personalità, bensì la arricchisce, e le consente di svilupparsi, di continuare a vivere, di permanere nell’essere. Da principio dunque, prima di acquisire un senso filosofo più tecnico, più complesso, la parola «bene» ha avuto un significato semplice, elementare. All’inizio dell’Etica Nicomachea, Aristotele, poco dopo aver affermato che il bene è ciò che tutti gli uomini perseguono, afferma che quando si persegue il bene e ciò che questa parola indica, si persegue, nello stesso tempo, la felicità, la eudaimonia.
La parola «eudaimonia» è composta da due termini. Il primo è «eu», che vuol dire bene, buono, in modo buono. L’altro è «daimon», che significa demonio, o meglio un piccolo dio, un dio particolare. Il termine non si riferisce dunque alla possibilità dell’essere umano di conseguire la propria felicità, bensì a ciò che gli dèi possono accordare.
In un altro luogo dell’Etica Nicomachea Aristotele cita un brano della tragedia greca in cui si afferma che chi ha un buon «daimon» non ha bisogno di amici. Sembrerebbe dunque che, in un primo momento, la felicità fosse considerata come indipendente dalla volontà dell’uomo e legata ad altre forze, ad altri esseri, misteriosi personaggi che, gratuitamente e liberamente, ad alcuni concedevano beni, e ad altri li negavano. È chiaro che questa prima idea di felicità derivava da una concezione, o meglio da un’ideologia, legata alla constatazione che c’era chi aveva molto e c’era chi aveva poco. Il mondo era avaro, la vita era povera o, per meglio dire, i beni erano scarsi, e tale arbitrarietà nella ripartizione dei beni che agevolano la vita dovette sbigottire certamente i Greci, prima che sorgesse una teoria, una filosofia della felicità.
Questa idea di «eudaimonia», ha conosciuto tuttavia un’evoluzione durante il corso della storia della filosofia greca, fino a divenire qualcosa di conseguibile, dipendente dalle energie e dalle possibilità umane. Di conseguenza l’eudaimonia, la felicità, ha smesso di essere uno stato passivo, di esclusivo godimento corporale, e ha cominciato a essere considerata come un processo, una lotta, una tensione, un percorso, un progresso verso una struttura di adeguamento dell’io, della persona, del soggetto, al mondo circostante. Intesa in questo senso, l’eudaimonia può essere vista come un processo democratico – come è possibile constatare nella storia della filosofia greca – collegandosi essa con l’evoluzione di una società in cui ormai non si dipendeva più da quanto gli dèi concedevano arbitrariamente.
L’eudaimonia entra così in rapporto con le possibilità offerte da una società nella quale tutti gli elementi che la compongono collaborano a un progetto comune. La felicità dell’individuo, del soggetto, si trova perciò a essere condizionata e determinata dalla felicità altrui. La parola eudaimonia è in effetti una parola-chiave perché corrisponde ai bisogni individuali e collettivi legati a quel «bene comune» che pone gli uomini in tensione reciproca e che tutti cercano per la propria soddisfazione, come rapporto con il mondo attraverso il proprio io.
4. Che rapporto sussiste la parola «to agathon», il bene, e l’«eudaimonia», la felicità? Oggi vengono ancora usati in maniera corretta?
Il termine bene prima di diventare un concetto astratto dell’etica e della teoria politica indicava qualcosa di utile alla società della quale l’individuo faceva parte. Il bene era qualcosa che si faceva in rapporto ad altri, e mediante questo fare, si trasmetteva una certa forma di utilità. All’inizio il bene era dunque collegato con il sentimento o, per meglio dire, con l’idea di utilità collettiva, sociale, familiare. I due termini «eudaimonia» e «bene» sono quindi uniti da una lunga storia, che poi diventerà la storia di due concetti fondamentali della teoria e della filosofia etica.
Tuttavia occorre ricordare che questi concetti, così importanti per la mentalità degli uomini, per il loro modo di capire e di interpretare il mondo, erano radicati nella nella vita e nei bisogni di questi. Io ritengo che in un mondo come il nostro, cosi dominato dai mezzi di informazione – dominio che non possiamo evitare, e che della nostra società è parte, se non necessaria, quantomeno costitutiva – sia importante che i termini non si logorino. Poiché li ripetiamo e li utilizziamo tanto, la ricerca della loro origine, del loro sangue, della loro carne, della loro linfa, potrebbe costituire un elemento importante per volgerci di nuovo verso noi stessi, per ricominciare a pensare il nostro linguaggio, ormai lucidato, levigato, prosciugato e smerigliato. I termini del nostro linguaggio sono infatti così inamidati che ci scivoliamo sopra e non riusciamo a vedere quel mare profondo, pulsante di vita, che sta nascosto sotto a essi.
Mi è capitato a volte di pensare che in molti manuali, in molti libri di filosofia – senza nulla togliere all’importanza di tali opere – è come se il mare della storia si fosse cristallizzato. È come se, a causa dell’uso così frequente e così spesso triviale dei concetti filosofici, il mare della storia si fosse congelato, e noi vi pattinassimo e scivolassimo sopra, sfruttandolo, umiliandolo; dimenticando così che questo enorme mare è vivo e pieno di pesci, ovvero è pieno di problemi attuali, e che è lo stesso mare sulla cui riva stavano i Greci. Noi stiamo sulla riva opposta, ma il mare è lo stesso, l’acqua è la stessa, e persino i pesci sono gli stessi.
5 Qual è il rapporto tra lo zoon politikon), l’uomo sociale e la polis?
L’espressione greca «techne politiche» indica la politica, la teoria della polis, e la polis era, per i Greci, uno spazio reale, un luogo, un «topos», una realtà nella quale si viveva e si esisteva. Ma, oltre a esprimere questo concetto di realtà storica, fisica, nella quale si abitava, polis significava anche reticolo, indicava cioè un sistema di relazioni fra gli uomini, una forma di organizzazione della vita delle persone, degli individui che risiedevano in un determinato territorio.
Non è strano quindi che Aristotele abbia definito l’uomo in modo così radicale e deciso: animale politico. Un animale esattamente uguale a tutti gli altri, e che come essi respira, digerisce, vede, sente. Ma con una differenza essenziale: ovvero deve vivere insieme ad altri, in comunità. È vero che ci sono altri animali – e Aristotele lo rammenta nel medesimo contesto della Politica – che vivono in comunità, ma, sempre secondo Aristotele, il modo di vivere in comunità di questi animali è un modo gregario, mentre l’uomo non vive gregariamente in una comunità, ma costruisce un suo sistema di relazioni per rivolgersi agli altri, per organizzare gerarchicamente o pariteticamente i suoi rapporti con gli altri.
Per questo è importante ricordare che Aristotele, nella stessa pagina in cui definisce l’uomo come animale politico, lo definisce anche come zwon logon ecwn (zoon logon echon), che letteralmente significa: «animale dotato di parola», o per meglio dire: «animale dotato di logos». È singolare che questa definizione aristotelica dell’uomo abbia dato origine all’altra famosa definizione secondo la quale «l’uomo è un animale razionale». Non era infatti questo ciò che Aristotele intendeva. Egli voleva dire soltanto che l’uomo è un essere che parla, che muove la lingua, e muovendola produce dei suoni semantici che creano comunità, che creano polis, ovvero uno spazio collettivo. Dunque è interessante osservare che entrambe le grandi definizioni aristoteliche dell’uomo – animale politico e animale dotato di logos – sono unite, poiché la politica e il possesso del logos si necessitano reciprocamente. Non esisterebbe politica, non esisterebbe reticolo collettivo, uno spazio di intelligenza collettiva, né gli uomini potrebbero vivere in società, in modo comunitario, se non parlassero o, per meglio dire, se non comunicassero fra loro. Questo è vero anche in una società come la nostra.
Io credo che se Aristotele, o una mente dotata di capacità sintetiche e analitiche come quella di Aristotele, potesse vivere oggi, rimarrebbe stupito nel rendersi conto di come l’uomo, oltre a essere un animale politico, un animale che ha bisogno di strutturarsi e di vivere in modo strutturato, è essenzialmente un animale dotato di logos, un animale che comunica. Oggi infatti l’affermazione dei mezzi di comunicazione di massa, costituisce la conferma definitiva del logos aristotelico.
6. Non c’è il rischio che lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa impoveriscano il linguaggio?
Mai come oggi l’uomo ha avuto tanti mezzi di comunicazione, e tante possibilità per essere in contatto con gli altri. Ma nonostante l’immensa quantità dei mezzi e delle possibilità di comunicazione, l’uomo è più solitario, più indifeso, più scoraggiato e disperato che mai. Ritengo che i filosofi, e in generale ogni persona cosciente dello stato attuale del mondo dovrebbero affrontare questo problema così importante, doloroso e difficile. In quanto la povertà di ciò che viene comunicato, la mancanza di riflessione su ciò che viene comunicato, rischia di modificare la vita mentale degli uomini, e condizionare i rapporti umani.
La filosofia, infatti, ha sempre rappresentato una coscienza critica all’interno della storia, una riflessione sulla vita, sui problemi concreti degli uomini. In ogni epoca, il pensiero filosofico è sorto dal rapporto dell’uomo con il suo mondo, e non c’è nulla di più sbagliato dell’idea che il filosofo sia un personaggio immerso in un mondo di idee che nessuno comprende, un mondo di problemi che non interessano a nessuno. Qualsiasi pensiero filosofico, qualsiasi questione filosofica è sorta in rapporto con il reale, con gli uomini.
Molti sono gli esempi che potremmo riportare di filosofi che si sono posti come coscienza critica del loro tempo. Basti pensare a quel famoso testo di Epicuro, dove si legge che sarebbe cattiva la filosofia che non servisse per curare alcune malattie degli uomini. È chiaro che oggi le malattie degli uomini si curano con la medicina e non con la filosofia. Ma la scienza dovrebbe basarsi su un sostrato che, in qualche modo, si pone i problemi filosofici dell’umanesimo. È vero che la parola «umanesimo» è molto decaduta e corrotta. Ma l’ideale dell’umanesimo, oggi più che mai, andrebbe resuscitato. Ovviamente sapendo riconoscere un utilizzo della parola «umanesimo» teso a trasmettere qualcosa di ingannevole, o a dissimulare i veri problemi, o a offrire una sorta di lenitivo per attenuare i problemi fondamentali del nostro tempo.
7. La polis greca, intesa come relazione fondamentale fra gli uomini che vivono in comunità, al di là della famiglia e dei legami della vita contadina, non ha forse favorito la nascita di una terminologia politica in uso ancora oggi?
La polis ha certamente avuto una storia determinata, condizionata dall’evoluzione stessa della società greca; non è un caso che la struttura della polis, quale organismo al cui interno gli uomini potessero convivere, è qualcosa di molto diverso dalle strutture collettive all’interno delle quali altre culture, altre civiltà, hanno vissuto. I Greci, poi, hanno creato il vocabolario politico. Infatti, sia nella Repubblica di Platone, sia nella Politica di Aristotele, si parla sia di regimi politici, sia del modo in cui, dentro la polis, era possibile raggiungere la felicità e il bene dell’uomo. Per questo i Greci hanno espresso in termini specifici le forme di organizzazione della vita all’interno della polis, creando parole come aristocrazia, democrazia, oligarchia, timocrazia, tirannia. Questi termini, corrispondevano a modelli secondo i quali si viveva e si organizzava la città, della quale entravano a far parte classi diverse, interessi diversi, tensioni diverse, ricchezze diverse, livelli di cultura diversi.
È molto interessante, poi, che queste parole costituiscono il vocabolario più vivo e più reale della cultura politica contemporanea. Aristocrazia, oligarchia, tirannia non sono termini pertinenti esclusivamente all’archeologia della storia greca. Oggi infatti esistono tirannie, oligarchie, aristocrazie, democrazie, demagogie, anche se non certo uguali a quelle dei Greci.
Tuttavia attraverso i mezzi di comunicazione di massa, con la finzione, la menzogna, col non ricercare la verità, è possibile creare false democrazie, false aristocrazie, false oligarchie e false tirannie. Infatti, una delle cose più interessanti della cultura greca, e che dai Greci abbiamo avuto in eredità, è l’idea di «bene apparente», che Aristotele analizza concretamente nell’Etica Nicomachea e in altre sue pagine. Si tratta della scoperta che, insieme al perseguimento del bene in quanto tale, è possibile perseguire un bene apparente, un bene che può non essere altro che una proiezione dei nostri desideri, dei nostri interessi.
Naturalmente l’idea di «bene apparente» – (phainomenon agathon), il bene fenomenico- aveva un ulteriore aspetto filosofico che concerneva quello spazio esistente fra l’idea del bene, e la soggettività e il mondo storico nel quale questo bene apparente si situava.
8. Nel mondo contadino arcaico la tribù, la famiglia, era la struttura fondamentale della società. In questa dimensione era difficile che si sviluppasse un concetto di individualità, che l’uomo si sentisse diverso dagli altri e, contemporaneamente, insieme agli altri. Non è dunque con la polis che si creano le premesse per lo sviluppi dell’io, dell’individualità?
Per i Greci, come probabilmente per molte altre culture, il clan familiare, il vincolo di sangue, è stato il primo fattore di legame; in altre parole, gli uomini si sono sentiti parte di uno spazio collettivo a partire dal clan familiare. A questo proposito è interessante rilevare che le parole greche «philos» e «philia» – amico e amicizia – in origine erano legate alla consanguineità. La parola «philia» nei primi testi dove appare, indicava infatti il vincolo che univa coloro che avevano lo stesso sangue, che avevano gli stessi progenitori, e che, dunque, appartenevano allo stesso clan familiare.
Successivamente la parola «philia» si è evoluta e ha cominciato a indicare un vincolo che univa persone che non avevano niente in comune dal punto di vista della consanguineità. Questa evoluzione è collegata con lo sviluppo della democrazia che si verificò in Grecia nel V secolo a.C.. Con l’avvento della democrazia, del demos, del popolo, con l’avvento della coscienza che la verità non era più appannaggio esclusivo di una dominante classe superiore; con l’avvento della coscienza che il linguaggio non era solo linguaggio del potere, e che le parole si potevano discutere e analizzare, si verificò un mutamento nel concetto di individuo e di individualità.
Ciò avvenne anche grazie all’impulso dato dai sofisti, che indubbiamente furono dei rivoluzionari nel senso più creativo della parola. I sofisti infatti spezzarono lo schema autoritario della parola del potere, che l’uomo greco ascoltava e assumeva passivamente. Dal momento, quindi, in cui la verità, la «aletheia», si poté discutere, dal momento in cui non fu più necessario accettare il discorso del potere e accettare la parola dell’altro perché gerarchicamente posto al di sopra; dal momento in cui, con i sofisti e con la discussione nell’agorà, nella società greca si compì questa rottura, l’uomo non solo scoprì un nuovo concetto di verità, ma, nel contempo, scoprì la sua intimità, scoprì se stesso, e comprese che il suo io poteva chiedere al linguaggio che cosa è la virtù.
9. Il fatto che Platone scrivesse dialoghi, non potrebbe essere un sintomo della scoperta delle diverse soggettività?
Nei suoi primi dialoghi, Platone, dando spazio ai problemi della sofistica, fece in modo che la gente parlasse, dialogasse così che la sua opera filosofica è un’opera dialogica. In realtà, i dialoghi di Platone sono stati il primo grande blocco della cultura filosofica. Prima di lui, infatti, ci sono stati i filosofi presocratici, le cui opere, i cui ipotetici scritti, non sono giunti fino a noi, se non in frammenti. Pertanto il primo grande blocco di opere filosofiche, la prima grande voce che, quantitativamente, si è espressa con abbondanza, è la voce platonica.
Tuttavia la voce platonica è una voce spezzata, incrinata da quella di centinaia di interlocutori dei dialoghi, che propongono la loro verità, che manifestano le loro idee, le loro prospettive, i loro punti di vista rispetto alla realtà. Platone dunque scrivendo dialoghi, espose un logos spezzato, e, in fondo, questo rappresentava anche la scoperta della soggettività, la scoperta dell’individualità.
Mai la filosofia è tornata a esprimersi in questo modo. È ben vero che Galileo ha scritto dei dialoghi, e che gli empiristi inglesi hanno espresso le loro idee in forma di dialogo, ma si tratta di un altro tipo di dialogo, dove l’interlocutore si produce in un lungo, immenso monologo. I dialoghi di Platone invece, soprattutto quelli della prima fase e della maturità, hanno altre caratteristiche: i personaggi che parlano sono individui, non meri nomi, etichette, che sciorinano un discorso tecnico, scientifico o ideologico, interessante ma monologico. I protagonisti dei dialoghi platonici, invece, in un incrociarsi di sistemi, o meglio di prospettive, di passioni, di interessi, esprimono la loro concreta e singolare individualità.
Ciò costituisce qualcosa di molto importante, soprattutto se si pensa al mondo contemporaneo. Infatti riflettendo sui dialoghi platonici – su quel dialogo continuo, quella ripartizione dei concetti a varie voci – si scopre la necessità di non assumere ciò che proviene dall’esterno passivamente, ma di rimetterlo in questione, discuterlo e offrirlo all’altro affinché manifesti il suo assenso o il suo dissenso, attraverso un logos che è vita, un logos che è «dia-logo», un logos che circola, che non ristagna negli angusti spazi del potere, dei mezzi che controllano, distribuiscono e amministrano il linguaggio.
10 Qual è l’origine e il significato della parola filosofia?
L’uomo è un animale che parla, che si esprime, che ha bisogno di pronunciare la sua lezione, di cantare la sua canzone, o, in altre parole, è un animale che ha bisogno di manifestare il suo essere all’altro. Ma oltre al legame fra gli uomini rappresentato dal logos, esiste una forma di legame non ascrivibile al mondo astratto dei significati, e che si riferisce invece all’affettività. L’uomo è un essere che si apre agli altri, che ama, secondo una necessità naturale. Tale necessità è riscontrabile già nel rapporto madre-figlio, dove la madre ama il figlio, si dedica a lui, e il figlio, per ragioni magari diverse, è aperto nei confronti della madre.
Questa apertura verso gli altri, questo uscire da sé, i Greci lo definirono con il termine «philia». L’uomo, infatti, non può stare rinchiuso in se stesso, non è assolutamente un monticolo di solitudine, in quanto è un essere naturalmente aperto. E il vincolo corrispondente a questa natura aperta è un vincolo affettivo, un vincolo di amore per l’altro, che porta a voler realizzare il proprio essere riconoscendosi nell’altro e volendo che l’altro ci riconosca.
Ma, indipendentemente da queste, che potrebbero sembrare elucubrazioni psicologiche o metafisiche, in effetti, è singolare che la parola filosofia sia composta da due termini:«philia», e «sophia». Ma non è del tutto esatto tradurre sojia con la parola sapienza, tradurre philia con la parola amore, e quindi il termine filosofia come «amore per la sapienza». Questo perché philia non significa soltanto amore, né sophia soltanto sapienza. Filia significa tendenza, proiezione, relazione, e anche possibilità che gli altri, che sono oggetto della nostra ricerca, rispondano agli interrogativi che poniamo loro. E sophia significa per i Greci il saper fare qualcosa, avere contatto con il mondo.
Il «sophos »era colui che sapeva fare qualcosa: una nave, una lira, un’anfora. La sapienza non è infatti nata come speculazione astratta: all’inizio i sapienti non erano soltanto coloro che sapevano pronunciare un discorso sulla vita e che potevano orientare l’uomo in essa. I sapienti, «oi sophoi», erano in primo luogo «coloro che sapevano», i tecnici: quelli che sapevano fare qualcosa con le mani. E come avrebbe potuto fin dal principio la parola sapienza significare una cosa astratta? La prima cosa che gli uomini fecero fu manipolare il mondo, toccarlo con le mani, trasformarlo. E dunque, prima del sophos inteso come colui che ha la sapienza, c’era il sapiente inteso come colui che sapeva modificare il mondo.
Di conseguenza nella parola filosofia è senza dubbio presente l’aspirazione a un sapere che interpreti il reale. Ma tale termine – che appare per la prima volta in un famoso frammento di Eraclito, dove si dice che gli uomini filosofi è opportuno sappiano molte cose, che siano al corrente di molte cose, che siano «istores»-, all’inizio, indicava il rapporto di conoscenza, di interpretazione e di valutazione dell’uomo nei confronti delle cose. Vale a dire, l’apertura dell’uomo verso le cose per utilizzarle e in qualche modo dominarle. Naturalmente la parola filosofia ha avuto una sua evoluzione, ma, a mio parere, ciò che la caratterizza è legato a questo significato primario di tendenza e di apertura verso la conoscenza, di ricerca della conoscenza.
11. Qual è il contributo fondamentale che la sofistica apportò alla cultura greca?
La ridicolizzazione dei sofisti da parte di Platone, il quale, nonostante il rispetto comunque presente nei suoi dialoghi, come nel Protagora e nel Gorgia, presenta la sofistica come una forma di pensiero ingannatoria, che ribalta le cose mettendo sopra quel che sta sotto, è una presentazione parziale, una deformazione. Tuttavia si tratta di una deformazione interessante, perché consente di vedere la sofistica a partire dalla prospettiva platonica, ovvero, da una prospettiva aristocratica. Ma, per quel che si può capirne leggendo Senofonte e Platone, i quali offrono versioni non del tutto coincidenti sulla sofistica, i sofisti non furono solo dei tecnici, anche se si racconta che alcuni di loro si fabbricavano le scarpe o i vestiti.
A ogni modo c’è invece un punto sul quale Senofonte e Platone concordano, ed è quello che riguarda la critica del linguaggio realizzata dai sofisti, il suo ripensamento costante, la revisione di concetti già in parte anchilosati, disseccati. Perciò i sofisti sono stati, nell’ambito della comunicazione intellettuale, dei rivoluzionari.
Certamente il verbo da cui proviene la parola sofista significa all’incirca «rigirare eccessivamente le cose», e certamente i sofisti hanno talvolta passato la misura, soprattutto quelli appartenenti alla seconda sofistica. Ma, ciononostante, mi pare che la critica di Platone ai sofisti sia, in un certo senso, esagerata, e oserei dire anche in qualche modo ingiusta. Perché pur con tutte le esagerazioni che si possono attribuire ai sofisti, pur col cattivo uso che possono aver fatto della revisione dei concetti, a loro dovremo sempre l’aver dinamizzato i concetti, l’averli fatti fluire, o, come direbbe il poeta Alberti, l’aver «reso l’anima navigabile», resi navigabili i concetti.
C’è poi un’altra parola-chiave della cultura greca, paideia (paideia) o educazione, che i sofisti rimisero sul tappeto, riportarono in piena luce, e sulla quale insistettero. L’uomo è oggetto di educazione: l’animale che parla, attraverso il linguaggio può arricchirsi, svilupparsi, crearsi. Ed è chiaro che questa creazione, questo sviluppo, questo arricchimento, sono connessi al rapporto con gli altri individui che costituiscono una comunità. Va rilevato che la democrazia funziona o può funzionare perfettamente, con la massima perfezione possibile, solo quando esiste educazione, quando esiste paideia. È interessante constatare che il popolo greco, che ha inventato la democrazia, definì la paideia, l’educazione, come quel fenomeno parallelo che consente alla democrazia di consolidarsi e di crescere.
Ritengo che il rapporto fra democrazia e educazione sia uno dei problemi della società contemporanea. E, pur non volendo fare il profeta, credo che la democrazia sia condannata al fallimento se non verrà fecondata con l’educazione, con la paideia. Una democrazia con una cattiva educazione, una democrazia «deformante», una democrazia dove si coltivi la menzogna, è una democrazia condannata, senza futuro, nata morta, senza possibilità di crescita.
12. In Italia il ministero che presiede alla scuola si chiama Ministero della Pubblica Istruzione. La parola educazione è stata eliminata, anche formalmente, dal rapporto con la scuola, e quindi con la formazione sociale e culturale del cittadino. Non ritiene che sia pericoloso per la democrazia quando che l’educazione venga ridotta al semplice rango di istruzione e di informazione?
Io credo che nel mondo dell’informazione, nel mondo dell’informatica che oggi ci domina, sussista il pericolo di trasformare il sapere, la conoscenza, in mera informazione. Eppure, ciò che caratterizza l’uomo non è tanto il sapere, la quantità di informazioni di cui può disporre – a questo scopo esistono già, appunto, i cervelli elettronici, i computer – quanto la capacità di pensare, di rinnovare il suo sapere, di rivederlo, di ricrearlo. E in una cultura come la nostra, trasformare l’educazione in istruzione significa trasformare gli individui in monticoli, in piccoli nuclei di piccoli saperi assolutamente parziali, senza collegamento con gli altri saperi, con i saperi della realtà totale.
Se continuiamo così, temo che la parola educazione si cristallizzi, si solidifichi e diventi priva di ogni significato. Perciò credo sia importante coltivare il pensiero. E nell’educazione oggi, nel rapporto fra i professori e gli studenti, nell’organizzazione della scuola, e anche nel mondo dell’informatica e in quello dell’informazione, va stimolato come non mai, guardando al futuro, il pensiero: il pensiero libero, il pensiero che crea, il rinnovamento intellettuale. Altrimenti credo che saremo condannati a un inaridimento, a un esaurimento del nostro orizzonte di possibilità.
Per questo oggi la filosofia, nonostante i molti problemi che il pensiero filosofico soffre nel mondo contemporaneo, deve porsi questi problemi e definire un orizzonte verso il quale proiettarli: l’orizzonte «umanista». Non mi vergogno a usare questa parola tanto deteriorata, in quanto è una parola che discende dalla miglior tradizione filosofica greca, da quella tradizione che faceva dire ad Aristotele che non gli interessava tanto sapere che cos’è la bontà, ma gli interessava che gli uomini fossero buoni, ossia che si creassero delle istituzioni, degli spazi pubblici dove la bontà, lo sviluppo dell’individuo, fossero possibili e realizzabili.
Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Palazzo Serra di Cassano, 21 aprile 1988